 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Gli addetti ai lavori dicono che un libro duri non più di sei mesi. Fortunatamente, ce ne sono alcuni che, per loro meriti, durano ben di più. Uno di questi è “Inclini all’amore” di Tijana M. Djerković, edito da Playground nel 2013. Un romanzo già affascinante dal titolo, da quel termine, “inclini”, così poco inflazionato e così tanto, per questo, affascinante. Un romanzo, come la Djerković stessa ha scritto”, pensato e (soprav)vissuto in italiano, “la mia seconda lingua madre”. Ed è forse ancora più sorprendente se si considera che il libro racconta le storie di una famiglia montenegrina, dalle vicende del nonno, Milovan, a quelle della nipote, Arianna, attraversando una parte fondante di storia europea.
Ma la Storia è sfondo, scenario nel quale si dipanano, ben più importanti e decisive, le storie dei personaggi nella loro ricerca continua, strenuamente motivata dell’amore, come unico motore e significante. In particolare, assume contorni densamente romantici la figura del padre, Vladimir, che dopo l’esperienza della guerra diverrà poeta, trovando nella dimensione letteraria un canale preferenziale di impegno e azione. La figura è in realtà quella del padre della scrittrice, Momčilo Djerković, una cui poesia la Djerković ha posto in apertura del volume, come sigillo a questo romanzo breve ma denso, scorrevole e chiaro come un bicchiere d’acqua: “Parla, che la casa non rimanga sorda, / che la pietra non si spacchi, / che l’acqua non perda il suo ritmo. // Che in casa echeggino le voci dei bambini, / che la casa non diventi sorda, / mentre la vita cresce e si dirama”.
È la memoria, il potere più grande che ognuno ha a disposizione. Perché ogni uomo è portatore di una memoria: non soltanto sua personale ma collettiva. Di un immensa ricchezza fatta di ricordi, di emozioni, di vissuti che non possono (e non devono) andare persi, ma devono contribuire a rendere più ricco e più profondo il domani di ogni altro. E “Inclini all’amore” è proprio un lungo racconto di memorie, un rincorrersi e accavallarsi, un sovrapporsi e intrecciarsi di caratteri ereditari, di vicende comuni che si ripetono (anche se in forme leggermente diverse). È anche un percorso personale, un’indagine intima di chi si scopre a voler mettere in ordine i suoi bagagli e a far i conti col suo passato, ingombrante e denso di storie e volti. È il recupero di un’identità (se di identità si può parlare) che non sia soltanto quella familiare ma si caratterizzi anche per la sua unicità e inequivocabilità, per il suo carattere esclusivo. “Inclini all’amore”, con il suo italiano cristallino e quasi intagliato, un italiano scelto come lingua amata (e non come lingua imposta), è una lunga favola, raccontata alla luce calda di un camino, durante una profonda e fredda notte invernale, in mezzo alle persone amate, che ci accompagna ininterrotta fino all’alba, quando ai primi raggi del sole ci si scopre persone migliori.
Tag: 2013
La giungla pittoresca dei premi letterari in “Selezione naturale”.
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – L’Italia esplode di premi letterari. Bandi e concorsi che allettano e illudono centinaia di scrittori o di aspiranti tali che conquistano pergamene e scarse motivazioni. La casa editrice di Orbetello, l’Editrice Effequ, ha edito una divertente antologia di racconti, “Selezione naturale. Storie di premi letterari” che mette assieme la genialità di scrittura di numerosi giovani scrittori toscani. I racconti, curati da Gabriele Merlini, hanno tutti come tema la scoperta e la conquista di un premio letterario da parte di scrittori spesso in erba, o da affermati narratori che, loro malgrado, sono nominati giudici e devono alimentare le illusioni di scribacchini vari.
La passione per il premio letterario ha una fenomenologia tutta sua, tutta particolare, tutta divertente e totalizzante. Stupefacente il realismo adesivo di Marco Simonelli, nel suo racconto “Patologia del premio di poesia”, dove la febbre del premio si fa accelerazione all’ironia. La fortunata stesura di un racconto, che detta il successo di uno scrittore per tutta la vita, nel racconto “Un racconto vincente” di Francesco D’Isa, è metafora di tanti premi dei giorni nostri, quando per vincere basta fin troppo poco e la fama è assicurata da praticamente nessun talento di scrittura. “Essi scrivono” di Alessandro Raveggi è invece parodia di una società di scriventi ma non di leggenti, di persone che credono tutte di aver qualcosa da dire ma che non si interessano a quello che hanno detto gli altri, in un solipsismo così esclusivo da risultare ridicolo. E poi ci sono anche i premi subito ripudiati, come nel caso di Vanni Santoni e nel suo “Il forca”, dove un intero romanzo, sudato in ogni pagina, finisce nel secchio dell’immondizia prima dell’ultima revisione.
Questi racconti, spietati e intelligenti, rendono uno specchio abbastanza convincente di un certo mondo letterario della nostra penisola, quello dove si nutrono false speranze e si premiano amici dei giurati; un mondo dove non si salvano neppure i premi ritenuti più importanti e blasonati, perché tutti finiscono nei medesimi meccanismi di interessi e visibilità editoriali. Una giungla è il mondo dei premi; una giungla dove le illusioni sono tante e i tentativi di rapina ancora di più. Basta prenderli un po’ con la giusta ironia e con una sana propensione all’indulgenza.
“Alla ricerca di un cuore”: il dramma di una famiglia.
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Le famiglie sono un luogo inospitale. Le famiglie sanno essere dispotiche e tiranniche, anche laddove si notano amore e devozione. Le famiglie sono spesso alle base di ogni problematica si sviluppa negli individui con il trascorrere del tempo. Il primo romanzo della giovanissima Manuela Melissano, edito da Lupo Editore nel 2013, ne è una narrazione dettagliata: in “Alla ricerca di un cuore” una ragazza appena ventenne di Lecce parte per la Francia con l’obiettivo di ritrovare sua sorella, scomparsa quando era molto piccolo, della quale non si avevano più notizie.
Manuela Melissano cura la scrittura, costruisce solidi personaggi a tutto tondo, sviluppa una trama che tiene appassionati anche se cede, qualche volta, a una specie di rassicurante ingenuità. Gli incontri sono fondamentali perché rischiarano lo sviluppo della storia e lo fanno proseguire a ritmo sostenuto e determinato. Sono proprio i personaggi che si caratterizzano per spessore e determinazione, in un’umanità densamente e fittamente popolata ma che offre esempi di tutte le tipologie e di tutte le variabili. I legami e i rapporti sono analizzati e discussi, quasi passati sotto la lente di uno scienziato. Anatomizzati con la fredda lama di un bisturi.
La narrazione, anche se ancora un po’ acerba, prosegue compatta e si dà forza mentre lentamente la protagonista, Elisa, scopre l’assenza di una sorella mai conosciuta e si delineano i rapporti di gelosie e di vendette che avevano covato nella sua famiglia, sotto le ceneri, come un incendio mai domato. Quella di Elisa non è soltanto un’indagine fortunata ma anche una ricognizione nei luoghi del dolore che appartengono a ogni nucleo familiare, a ogni relazione umana, a ogni contatto e scambio di sentimenti. E tutta la narrazione viene inquadrata in una cornice narrativa ben più ampia, in cui la scrittrice (che è Manuela Melissano) viene spinta dallo “spirito” di Elisa (la narratrice) a raccogliere le sue memorie di questa storia tanto strana quanto ahimè potenzialmente comune.
La ricerca della sorella diventa indagine persino di sé stessa, una sorta di formazione continua per l’edificazione di nuova “io”; la presa di consapevolezza che al mondo esistono percorsi accessori e impervi, che ci troviamo spesso di fronte a un bivio, a una strada a forma di “y”, come Elisa stessa confida nel libro. E sullo sfondo ci sono la disperazione e il dramma di una famiglia alla quale sparisce una figlia: storia simile a molte storie vere che sono accadute e che accadono nel nostro paese e che hanno popolato le cronache nere di riviste e telegiornali, dalla piccola Angela Celentano alla più recente Denis Pipitone.
“La vita ti sia lieve”: la dignità delle migrazioni.
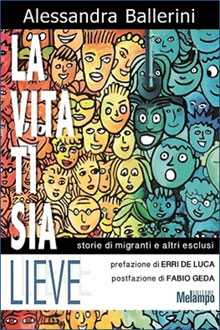 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Di migrazioni l’uomo non può farne a meno: inevitabili come l’essenza stessa del genere umano. Perché, dunque, esiste tanta ostilità verso i migranti? Perché tanta diffidenza, spavento, odio nei confronti in particolare di alcune categorie? Un ruolo, quello del migrante, che potrebbe per di più toccare a tutti, almeno una volta nella vita. Alessandra Ballerini è un noto avvocato di diritti umani e utilizza la scrittura, per sua stessa ammissione, come una “terapia ‘casalinga’”, per alleggerire il suo carico umano di fronte allo spettacolo di tanti diritti violati, di tanti torti e di tante sofferenze spesso istituzionalizzate. E il frutto di questa coraggiosa terapia è “La vita ti sia lieve”, edito nel 2013 da Melampo Editore con il patrocinio della Sezione italiana di Amnesty International.
Nella sua carriera, ma anche nel suo impegno costante a fianco delle ingiustizie, Alessandra Ballerini ha visto di tutto, come lei stesso ammette, in una lacrimante enumerazione, sottolineata da uno straziante ritorno anaforico di “Ho visto… Ho visto… Ho visto…”: vero e proprio manifesto, tanto da campeggiare in quarta di copertina, ad ammonire chiunque che il viaggio che si intraprende in queste pagine è un pellegrinaggio di dolori, di sofferenze, di omertà e di latitanze – le nostre – alle quali siamo chiamati a ribellarci, per far nascere (o risorgere) altre consapevolezza. La galleria dei personaggi della Ballerini è tutta dolorosamente umana, realmente esistente e calpestante strade. I suoi personaggi, quel Said, quella Olga, quella Ana e le figlie, quella Claudia e Doris e Alexandra, tutte quelle altre, sono persone con volti, profili, occhi scavati, corpi spesso violati, paure più reali della loro stessa esistenza. Potremmo incrociarli magari in ogni strada, potremmo superficialmente ignorarli alla fermata di un autobus o distrattamente maltrattarli in fila al supermercato.
Ed è un’agghiacciante verità a esplodere da queste pagine: la complicità che anche noi abbiamo nell’architettura di questo nostro Stato. Che si vanta di avere una delle migliori Costituzioni del mondo, coi suoi splendidi primi articoli, ma che poi non prevede ancora la pena di tortura e che viola sistematicamente i principi costituzionali: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge” (art. 10). E se anche il principio non fosse stabilito dalla nostra Carta, esisterebbe ancora un diritto umano imprescindibile e inalienabile: quello che ha sempre reso lo straniero un ospite gradito, un “regalo degli dei”, un segno di fratellanza che potesse perdonare tutte le mancanze.
Lo stile di Alessandra Ballerini è asciutto, essenziale, senza fronzoli né orpelli. Uno stile lieve, come la vita che spererebbe per i migranti, di ogni provenienza e di ogni approdo. La Ballerini scrive l’essenziale perché spesso soltanto questo è necessario; e in tutto il suo essenziale non c’è nulla che manca per farci sentire colpevoli.
“Vegano alla mano”: il ricettario vegano facile e gustoso.
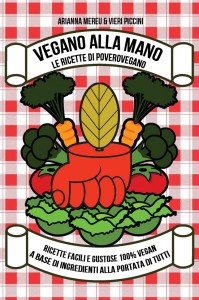 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Il concetto di partenza è chiaro: “Essere vegan non è complicarsi la vita ma semplificarla”. Eliminare carne, latte, pesce, uova e tutti i prodotti derivati dagli animali significa tornare a un’alimentazione basica e semplice, che segua il ritmo delle stagioni e che assecondi piuttosto i cicli naturali. Arianna Mereu e Vieri Piccini (assieme, il Poverovegano) hanno deciso, per questo, di offrire a tutti i vegani (ma anche a chi, non essendolo, non disdegna altro genere di piatti e di cibi) un ricettario vegano vario, completo ma di ricette estremamente semplici e facili da preparare: “Vegano alla mano”, edito da Ouverture Edizioni, casa editrice della Maremma toscana, racchiude, come recita il sottotitolo, “Ricette facili e gustose 100% vegan a base di ingredienti alla portata di tutti”.
I vegani non dimenticano una sola portata del pasto: si comincia con i condimenti e le salse, tra cui hummus, mayovegan e varie salse di crostini; si prosegue coi primi piatti: dalle zuppe al ginger, al riso sotto la palma con zenzero e cocco, ai poveroveganonigiri agli spaghetti del vagabondo con fichi e mandorle. Si passa poi ai secondi e ai contorni, dalla parmigiana di melanzane vegan agli involtini di verza speziati, alle frittelle rustiche ai nodi di patate ai carciofi. E non si può concludere se non con i dolci, dalla classica torta pere e cioccolato alla lacrima di Oaxaca, con cioccolato e avocado.
Ricette semplici, ben descritte, precise nelle misure e nei dosaggi, nelle miscele e nelle composizioni, pensati proprio per tutti, senza nessuna distinzione. Ogni ricetta è corredata da una foto e da alcuni consigli generali di carattere anche culturale, in un volume dalla grafica divertente e leggera: un ricettario da portarsi sempre dietro, che fa cadere ogni alibi alla fatica di cucinare e di abbandonarsi ai cibi precotti o già pronti.
Caratteristica comune di tutte le ricette, quasi imperativo morale dei due autori: la valorizzazione del cibo, per evitare che qualcosa di buono finisca sciupato o sprecato. Ma anche l’utilizzo di ingredienti piuttosto semplici e non cari, visto che non molti, come i due vegani scrivono nel manifesto di apertura, possono permettersi “di fare la spesa tutti i giorni ai negozi dedicati ad un’alimentazione perfetta”.
L’avventura vegan non è esclusiva né, come a molti potrebbe sembrare, comporta privazioni di gusti e sapori. Piuttosto, è una diversa concezione della cucina, una diversa valutazione del cibo, un’alternativa strada per il proprio benessere.
“La prigione degli stranieri”: un passato da cui non si impara mai niente.
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – In passato, esistevano i campi di concentramento. Pagina dolorosissima dell’umanità, raccapricciante nella lucida sistematicità dello sterminio. In realtà, di campi ne sono sempre esistiti, in ogni piega di mondo. Quasi irrazionalmente, l’uomo si è sempre più sentito sicuro sapendo che altre persone – quelle che, in quel dato momento, venivano sentite come più minacciose – fossero rinchiuse in un altro luogo, in un altrove di separazione. Il testo di Caterina Mazza, edito da Ediesse (2013), ci accompagna con perizia e competenza alla conoscenza de “La prigione degli stranieri”, ovvero i CIE (Centri di identificazione ed espulsione) che costellano la penisola italiana.
La storia dei CIE, che hanno cambiato un’infinita di nomi piuttosto grotteschi, ha le sue origini nel Trattato di Schengen, ovvero proprio in quel documento che voleva garantire in tutta Europa, per renderla più “unita” e meno “vincolante”, la libera circolazione di uomini e merci. Ma, parafrasando Orwell, anche in tema di libertà, alcuni uomini sono più uguali di altri. Il diritto fu garantito a chi fosse europeo, un po’ meno a chi fosse in Europa per lavoro, per studio, per richiamo familiare, per qualsiasi altro motivo.
Il concetto di libertà non richiama soltanto l’idea di potersi muovere senza vincoli e senza restrizioni, ma implica anche il sapersi sempre al sicuro, esente da rischi e penalità. Situazione che non si verifica oggi, dal momento che fino a qualche giorno fa l’immigrazione clandestina, ovvero il trovarsi sul territorio nazionale sprovvisti di un documento (visto o permesso) regolare implicava il commettere un reato penale. Significava che la stessa esistenza di una persona, la sua vita, il suo essere hic et nunc, fosse una colpa paragonabile a un omicidio.
L’adozione dei CIE non è solamente una decisione di casa nostra, ma come in tutte le cose peggiori, anche l’Italia si è adattata agli altri paesi europei: dalla Spagna alla Grecia, in particolare nella Svizzera e nei paesi del Benelux, esiste una galassia, più o meno legale, di centri di detenzione, dove stazionano per un tempo parecchio oscillante tutti i migranti, non importa neanche se minorenni, malati, donne, transessuali, in attesa di ottenere un documento dalle rispettive ambasciate che permetta di rimpatriarli nei paesi di origine. Son territori, i CIE, dove quasi non esiste legge, dove i diritti son calpestati continuamente, dove la mancanza di libertà è dovuta semplicemente a un colpa che, se vogliamo proprio definirla tale, appartiene alla sfera amministrativa.
Le migrazioni hanno caratterizzato da sempre la storia dell’umanità. Fermare l’uomo è impossibile, persino assurdo. Pretendere che l’uomo reprima il desiderio di sfidare gli orizzonti e di cercare un futuro e una speranza migliore per sé e la sua famiglia è grottesco. Ostinare a considerare i migranti come banditi, negandogli persino il diritto costituzionale della presunzione di innocenza, è incredibilmente criminale.
Il più surrealista “Campionario per una vita migliore”.
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Thomas Gunzig è probabilmente uno degli esponenti più illustri della contemporanea letteratura belga. La casa editrice Hop!, nella collana “Bonheur, i libri della felicità”, pubblica la coraggiosa raccolta di racconti “Campionario per una vita migliore” (2013). Si tratta di un vero e proprio campionario, di un catalogo di situazioni spesso accelerate all’eccesso, che tentano di scardinare le certezze della vita, di nobilitare le debolezze, di sottolineare gli eccessi, di dare significati e importanza agli eventi casuali e inattesi.
Le storie spesso riflettono un atteggiamento marcatamente grottesco, surrealista nelle svolte e nelle immagini. Spesso le storie raccontate sono crude, dure, difficili da masticare: come la breve piece teatrale “Pezzo di carne”. Il lettore, però, non è disorientato nella dimensione parallela narrata; non si sente fuori luogo o abbandonato a sé stesso. Proprio perché la scrittura è rigorosa e profonda, ben calibrata, essenziale senza nulla di superfluo, senza orpelli che la rallentino o la depistino. Sono schegge, questi racconti. Frammenti taglienti e ficcanti, dalla precisione di un bisturi. Aprono ferite sottili, ma inevitabili. E sorprendono per la perfezione della loro struttura, del loro impianto narrativo.
Paradossalmente, il percorso che ogni personaggio compie nei vari racconti approda alla felicità intesa in senso sommo, universale. Anzi, pare quasi che l’idea dominante sia quella di un compimento della catastrofe. Però, in realtà, si capisce ben presto come la felicità sia relativamente collegata al protagonista in questione; e che lo stesso protagonista, magari, non stia cercando una qualche forma di felicità ma semplicemente un punto di rottura e una deviazione, una svolta alla sua vita che pare perfetta ma che è incrinata e sull’orlo di un’implosione. Spesso la soluzione è data dalla scelta che pare meno opportuna, più foriera di catastrofe e di sofferenza. Il gioco della vita è crudele, spesso beffardo, ama la spietatezza e pare che si significhi solamente nell’afflizione che sa distribuire generosamente. Ma Gunzig ci avverte, col suo sguardo divertito e svagato, di non basarsi troppo sulla morale comune, di non misurare le prospettive su quelle della collettività dominante, ma di sapersi calibrare su altre gradazioni e tonalità che ci liberino e ci smarchino dalla schiavitù del perbenismo e del conformismo.
Thomas Gunzig ha una scrittura sfrontata e giocosa, una capacità di forzare la parola senza tradirla né snaturarla: gioco che riesce in maniera egregia anche nella traduzione, lasciandoci più o meno inalterato il senso di questi continui calembours. E la forzatura della parola è un modo per decomporre la realtà, deframmentarla, scorticarla, sventrarla e poi però ricomporla, ricucirla, rimodellarla nella maniera che lo scrittore presume più utile e significativa.
“Alla fine è la parola” che fa sopravvivere agli esili.
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Hilde Domin ha trascorso la sua vita in fuga, migrando di città in città, di nazione in nazione; di cultura in cultura: dalla Germania dei suoi padri ebrei a Roma e Livigno, dall’Inghilterra alla Repubblica Dominicana. La sua produzione poetica, fiorita negli anni di questo lungo esilio, fu per lei il tentativo concreto di difendersi dalla disgregazione e dall’ansia della persecuzione. Del Vecchio Editore ha intrapreso il “Progetto Domin”, la ripubblicazione delle sue poesie più interessanti e significative; nella collana Poesia è uscito, per questo, nel 2013, “Alla fine è la parola / Am Ende ist das Wort”. Questa antologia poetica raccoglie i componimenti più significativi e potenti delle sue raccolte, in particolare da “Solo una rosa a sostegno” e “Rientro delle navi”.
La lontananza è la materia feconda della tensione poetica della Domin, l’addio e l’abbandono ne sono costanti alimenti: “Scherziamo con gli addii, / collezioniamo lacrime come biglie / e proviamo se i coltelli tagliano”. Il verso della Domin è breve, estremamente asciutto, fiorito di parole quotidiane e piane, dense di significati e di prospettive: “Alla fine è la parola, / sempre / alla fine / la parola”. Una parola che, però, è costantemente frustrata dalla transumanza, dal percorrere terre straniere, dove si parlano altre parole, dove i concetti sono magari gli stessi ma incomprensibili a un primo ascolto: “Di dimora in dimora / oblio. / Il tuo nome / diventa qualcosa di estraneo”. La sua condanna è inesorabile, manca di difesa concreta: “Sono la straniera, / che parla la loro lingua”.
Tra le figure poetiche più intense ci sono sicuramente gli alberi, che si concretano come fondanti correlativi oggettivi: ogni diversa specie, attentamente nominata e individuata, ha un valore e un significato particolare, dalla distanza alla dimenticanza, dal ricordo al bisogno di vita: “Sono stata qui. / Passo, / senza traccia. / Gli olmi sulla strada / mi fanno cenno al mio arrivo, / un saluto d’oro verdeblu / e mi dimenticano / prima che vada oltre”. L’esistenza è, per Domin, leggera e senza peso, quasi volesse non provocare il minimo rumore, il più inatteso fastidio: “Prendi in mano una candela / come nelle catacombe, / la piccola luce respira appena”; anche in amore: “Il tuo nome sulle mie labbra, / sempre ai bordi dell’urlo, / non deve cadere a terra”.
Suo desiderio ultimo è sentirsi a “casa”, nutrendo il bisogno intimo di una terra con la quale poter avere un legame di profonda corrispondenza intima: “E da ciò riconosci / che qui / sei un po’ più / a casa / che in altri luoghi”. Hilde Domin ha, allo stesso tempo, bisogno di un forte ancoraggio a una terra che sia luogo definitivo (“Costruiscimi una casa”; “Le stanze in cui metterò le rose / perché ci sia qualcosa di mio”) ma conosce anche il bisogno di saper individuare, nelle lontananze, delle immagini comuni, delle esigenze universali: “Ovunque il fieno / accatastato in modo diverso / ad asciugare / sotto lo stesso / sole”.
Il ritorno è la sua ansia, la sua più forte tensione emotiva: “Vado / verso un’isola senza porto, / butto in mare le chiavi / già alla partenza. / Non arrivo da nessuna parte. / La mia vela è come una ragnatela al vento, / ma non si strappa. / E oltre l’orizzonte, / dove i grandi uccelli / asciugano le ali al sole / alla fine del volo, / c’è una terra / dove mi si deve accettare / senza passaporto, / con l’avvallo delle nuvole”. Se il migrare coatto, costretto, ha in sé un’idea struggente di vergogna (“Chi ha pianto sulla soglia di casa / come neanche un mendicante straniero. / Chi ha passato le notti sulle assi / a fianco del proprio campo. / Chi ha pregato i morti / di distogliere lo sguardo dalla sua vergogna”), il ritorno nutre in sé la scintilla della felicità: “Tu non sali. / La felicità non è un aereo, / non ha orari / né aeroporti. / È un grande uccello / che ne accoglie uno piccolo / sotto le sue ali”. Perché spesso ogni migrazione è, in realtà, un doloroso esilio.
“Lampedusa”, quale futuro per la porta d’Europa?
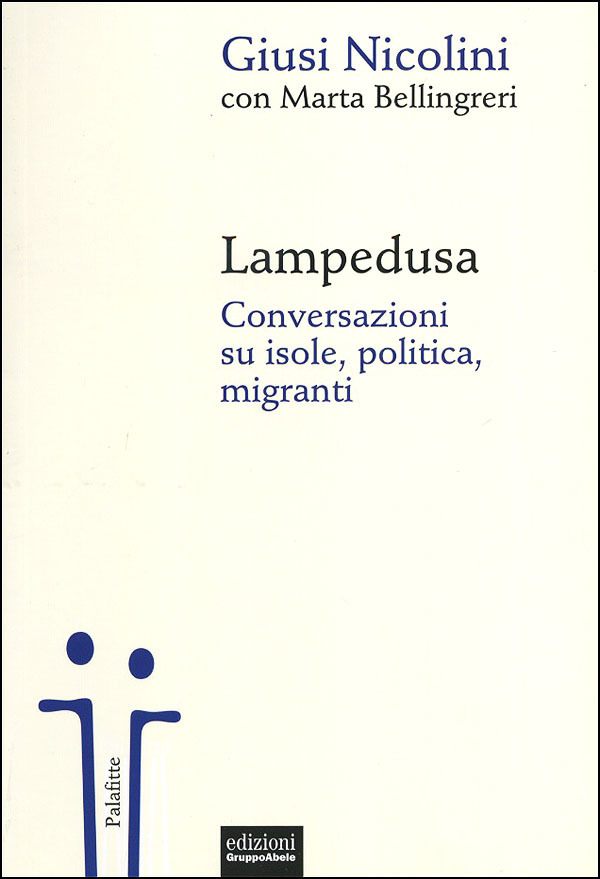 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Giusi Nicolini da sempre alza la voce in difesa di terre e uomini. Da quando è stata eletta sindaco, nel 2012, ha portato all’attenzione dell’Europa intera quei ventun chilometri scarsi di terra che amministra. Marta Bellingreri l’ha intervistata, nel luglio 2013, e questa lunga chiacchierata è stata pubblicata dalle Edizioni Gruppo Abele nel 2013 nella collana “Palafitte”. “Lampedusa. Conversazioni su isole, politica, migranti” è un manifesto di grande lucidità e acutezza, nel quale Giusi Nicolini, diventata uno dei sindaci più famosi d’Italia, racconta la sua storia, la sua decisione di dedicarsi all’amministrazione politica delle sue terre, e tratteggia con grande competenza quelli che potrebbero essere gli orizzonti futuri per Lampedusa, la porta dell’Europa.
Giusi Nicolini parla delle migrazioni, del ruolo che Lampedusa ha nell’accogliere le persone in fuga da una realtà feroce, da malattie, dalla guerra, dalla fame. Parla del cimitero che non basta, dei diritti negati anche da morti, parla dei tanti troppi minori non accompagnati che viaggiano sulle rotte del Mediterraneo e che sono abbandonati, senza cure né assistenza. Tra i tanti progetti realizzati si cita anche la Biblioteca dei ragazzi, realizzata grazie a un progetto di Ibby Italia, nella quale saranno utilizzati molti silent books, libri senza parole ma con tante immagini, realizzati per superare le barriere linguistiche tra i bambini italiani e quelli migranti.
Ma non ci sono migranti, nella storia di Lampedusa. C’è anche l’ambiente, una risorsa straordinaria che fino a pochi anni fa era seriamente minacciata dall’uomo e dai suoi abusi di vario ordine e grado. Quell’ambiente che recentemente ha conferito alla spiaggia dell’Isola dei Conigli il titolo di spiaggia più bella del mondo. Un riconoscimento anche al lavoro della Nicolini, che per tanti anni è stata responsabile di Legambiente della Riserva dell’Isola dei Conigli, una delle ultime spiagge europee dove si riproducono le tartarughe marine, le Carretta, che a Lampedusa vengono recuperate e, in un apposito ospedale, curate.
La lunga intervista con Giusi Nicolini mette in luce le potenzialità e le reali esigenze di un’isola, e di una terra, per lungo tempo dimenticata, trascurata ai margini dell’italianità in ogni settore, da quello scolastico-sanitario a quello sanitario, a quello dell’approvvigionamento idrico ed energetico. Un’isola che strategicamente ha la sua importanza, tanto da essere diventata sede di una base NATO, e di esser stata vittima di un attacco missilistico dalle coste libiche, nel 1986, ad opera del Colonnello Gheddafi.
Ma la Nicolini ha parole di accusa anche per la politica italiana, per i partiti, per i meccanismi del potere che vogliono sempre ricondurti in una definizione, in una schematicità. La sua battaglia si definisce quasi apolitica, sfidando preconcetti e pregiudizi che sono propri di intere collettività umane. I valori che sono difesi, le aspirazioni ventilate, gli obiettivi sperati sono patrimonio comune, non esigenze da manifesto partitico o campagna elettorale.
La “Scimmia nera” che ci cammina a fianco.
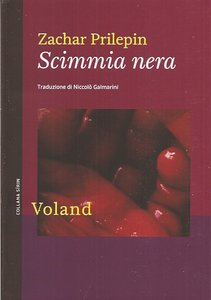 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – La violenza è dovunque. A ogni angolo, in ogni strada, dentro ogni appartamento; peggio ancora: in ognuno di noi. “Scimmia nera” di Zachar Prilepin, edito da Voland nel 2013 nella collana Sírin, ci fa sprofondare in questa banalità tanto sconcertante: non c’è luogo al mondo dove la violenza, in una qualche forma, non si palesi, dove non domini furiosa.
Partendo da una già strana inchiesta sulla violenza dei bambini, e documentando alcuni esperimenti di analisi e studio comportamentale di alcuni minori tenuti sotto vetro in un laboratorio occultato chissà dove, il protagonista della storia ci fa strada in una complessa vicenda di incontri e tangenze, tutte caratterizzate da una vena, più o meno densa, di violenza e sopraffazione, di angoscia e squilibri emotivi. A cominciare dalla sua relazione sessuale con una minorenne, per finire al cruento rapporto con la moglie e a una brutalizzazione estrema di ogni gesto della quotidianità più naturale e banale.
Il tentativo di capire come mai si studino i comportamenti di bambini all’apparenza normalissimi ma reputati capaci di estremi gesti di violenza, arrivando fino all’omicidio, crea nel protagonista un’ansia di documentazione, che lo induce a interrogare chiunque ritenga in possesso di informazioni o di particolari punti di vista. La sua è una ricerca perduta, un’immersione in una ferocia potente e totalizzante, un percorso che pare non avere nessuna soluzione: c’è solo il costante e irrecuperabile sentore di una dissoluzione, di una putrefazione anche umana. Perché la violenza trova sempre la strada per concretarsi, al di là di ogni difesa si possa pensare di innalzare, al di là di ogni intervento si possa realizzare (paradigmatica, in questo senso, la narrazione dell’assalto alla città da parte di fantastici eserciti di bambini senza paura). Ma la violenza spaventa ancora di più, perché tutti ne possono rimanere coinvolti; o, ancor di più, tutti ne potrebbero essere capaci. Come se a ciascuno di noi camminasse una scimmia nera a fianco; una sorta di ombra, presenza demoniaca, concretazione materiale del nostro lato più oscuro e più refrattario al controllo (razionale o meno, non spetta dirlo).
Il viaggio di Prilepin è quasi visionario, una corsa a occhi chiusi, un delirante rosario di azioni feroci e furiose; ma il tutto sublimato intensamente e drammaticamente (nel senso di potenza rappresentativa) da un afflato poetico ricco, che sublima e porta a perfezione ogni quadro, ogni narrazione, ogni episodio; anche i più confusi e mortificanti.





