 Marianna Abbate
Marianna Abbate
ROMA – Equitalia è un nome che incute timore. Un nome che toglie il sonno, che agita. Non sono lontane le notizie di cronaca che presentavano disperati mentre entravano negli uffici del riscossore tributario armati fino ai denti. Perché Equitalia arriva inaspettatamente, colpisce quando sei tranquillo.
Alzi la mano chi negli ultimi due anni non ha ricevuto nessuna cartella dal famigerato ente? Io personalmente ne ho ricevute diverse, principalmente per multe finite nel dimenticatoio. Ma se il mio sacrificio è stato abbastanza ridotto (sotto i mille euro), non mi è difficile immaginare il dramma di una famiglia che si vede arrivare una cartella da 10.000 euro, quando il reddito annuo non supera i 14.000. E tutto magari per un impagato da poche centinaia di euro cui si aggiungono multe su multe.
Ed ecco qui la storia delle storie raccontate da Giuseppe Cristaldi nel suo “Macelleria Equitalia”, pubblicato da Lupo Editore. Cinque racconti brevi, immagini di vita vissuta. Non sono storie complicate, sono storie vere. Fatti nudi e crudi, inquietanti nella loro inesorabilità. Microstorie racchiuse nella macrostoria che si sta compiendo ora nel nostro Paese.
Quello Stato che aveva fatto di tutto per includere, per diffondere, per uniformare… beh quello stesso Stato oggi esclude. Traccia una linea netta tra chi è nel giusto e chi ha peccato del più grave dei peccati: l’indigenza. Non avere diventa una colpa gravissima: A chi ha sarà dato e sarà nell’abbondanza; e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha.
Le parole dell’evangelista vengono interpretate nella concretezza più assurda e rimangono chiaramente incomprese.
Ad essere colpiti sono principalmente coloro che hanno da sempre fatto la ricchezza del paese, quei piccoli imprenditori che altro non sono che contadini, agricoltori, allevatori e artigiani. Quelli che hanno peccato nel modo più grave: non hanno pagato la Decima.
Ma se nel medioevo la Decima corrispondeva ad un decimo del raccolto, le tasse di oggi sono al 44%. Un peso insostenibile per chi già avrebbe problemi a contribuire con il 10%.
Tra guadagni presunti, valore aggiunto e scontrini il gioco non vale la candela, e così moltissime imprese sono costrette a chiudere i battenti. O non pagare le tasse.
Ma l’atto stesso di non pagare, di chiedere un dilazionamento, di cercare un po’ di respiro è un marchio indelebile sulla carne del malcapitato. Un segno che lo indica come parassita, grazie alla martellante pubblicità, come delinquente. Non importa se quelle tasse sono state sempre pagate: se hai mancato all’appuntamento non è perché sei povero, perché hai bisogno di aiuto, ma perché hai rubato. Hai nascosto nel materasso chissà quali tesori per acquistare una villa nei paradisi fiscali.
Ognuno giudica con il suo metro, e questo potrebbe farci comprendere molte cose. Forse lo Stato non riesce ad accettare l’idea che ci siamo impoveriti così tanto. Forse teme che tutto questo sia vero, nascosto dietro ai (poco) rassicuranti e (tanto) freddi numeri dell’Inps.
Ѐ questa l’Italia che ci racconta Cristaldi, l’Italia che cerca di rimanere a galla, che cerca di risalire il fiume. L’Italia che ogni giorno dimostra coraggio e forza di volontà e che un giorno tornerà a pagare tutte le tasse. Che, speriamo, non verranno più spese per pagare cenette romantiche e vacanze in yacht ai nostri cari politici.
 Marianna Abbate
Marianna Abbate




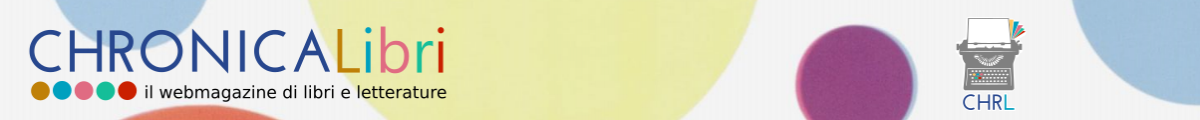

 Marianna Abbate
Marianna Abbate

 Marianna Abbate
Marianna Abbate

 Marianna Abbate
Marianna Abbate Marianna Abbate
Marianna Abbate