 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Se ne parla oramai da anni: il petrolio sta per finire. L’uomo sarà costretto a ripensare alla maniera con cui procurarsi l’energia per ogni aspetto della sua vita, anche il più minuscolo e insignificante. Le prossime guerre saranno tutte per la conquista di un bene più prezioso, più imprescindibile: l’acqua, senza il quale l’uomo neanche esisterebbe. Ettore Mo, giornalista di lunga e decorata esperienza sui fronti di tutto il mondo, nel suo libro “Fiumi” edito da Rizzoli, sceglie di esplorare altre trincee, altri luoghi di guerre più o meno silenziose e dimenticate: quelle che si combattono, appunto, per la conquista e il possesso dei grandi (o piccoli) corsi d’acqua.
Le grandi culture, si sa, sono sempre fiorite in prossimità di fiumi: dalla Mesopotamia, così chiamata per la fortuna di trovarsi distesa tra il Tigri e l’Eufrate, alla civilità egizia, dai Romani alle cultura della valle dell’Indo, dalla Cina al Sud Est asiatico. E da allora il corso dei fiumi ha attirato le attenzioni e le mire speculative di grandi gruppi privati e del potere pubblico. In epoca dell’esaltazione delle energie alternative, l’acqua ha smesso di essere considerata solo come importante per il soddisfacimento dei bisogni primari degli uomini o per la sua importanza agricola, ma si è quantificata per la potenza della sua portata.
Ettore Mo visita il mondo partendo dall’importanza culturale, religiosa, persino mistica, che questi fiumi hanno sempre rivestito per le popolazioni che sulle rive sono nate e si sono sviluppate: il Gange, il Nilo, il Giordano, lo Yangtze, il Mekong, il Rio delle Amazzoni, il Mississippi fino ai più nostrani Danubio e Piave. Nelle storie di Mo c’è il tentativo disarmante di far capire come tutti questi grandi corsi d’acqua e persino alcuni laghi (il Mar Morto, il Lago d’Aral, il Lago Bajkal) siano degli “agonizzanti”, destinati a scomparire dalle cartine geografiche nel giro di pochissimi anni. Non rimane quasi più nulla della loro storia gloriosa, del loro passato, della loro memoria di eventi e ricordi: basti pensare alle vicende della Prima guerra mondiale accadute sulle rive del Piave, o alle tante suggestioni letterarie che il Mississippi, nei romanzi da Twain a Faulkner, ha saputo nutrire e poi evocare.
I reportage di Ettore Mo si arricchiscono, però, anche di dati sulla contemporaneità. Sul faraonico progetto cinese della Diga delle Tre Gole, o sui tentativi del Brasile di sfruttare senza ritegno il polmone verde del mondo, la Foresta amazzonica, con le sue ricchezze di alberi, natura, acqua, sottosuolo. Ettore Mo ci ammonisce, snocciolando dati e presentando persone, famose o meno, che stanno pagando la loro voglia di resistenza. Ma ci ammonisca anche su quell’assurda pretesa dell’uomo di voler a tutti i costi, con ogni mezzo, con un’illusoria onnipotenza, imbrigliare la Natura e piegarla ai suoi biechi e miseri interessi, alle sue assurde pretese di crescita continua e inarrestabile.
Categoria: Letture vintage
“La notte”, il fumo, il freddo e Auschwitz
ROMA – “Questo è Auschwitz. Come fate a non sapere cosa succede qui, è il 1944!” Sono queste le parole che accolgono gli uomini frastornati, scesi appena da un vagone per bestiame, dopo un viaggio durato diversi giorni. Dopo un viaggio terrificante, stipati in ottanta, senza acqua e senza aria.
Cosa può esserci di peggio di questo?
Ce lo racconta Elie Wiesel, celebre sopravvissuto del campo di Auschwitz, nel libro forse più conosciuto sulla Shoah: “La notte”, edito da Giuntina.
“Volevo ancora le poesie, le stelle e i gelsomini, e te…”
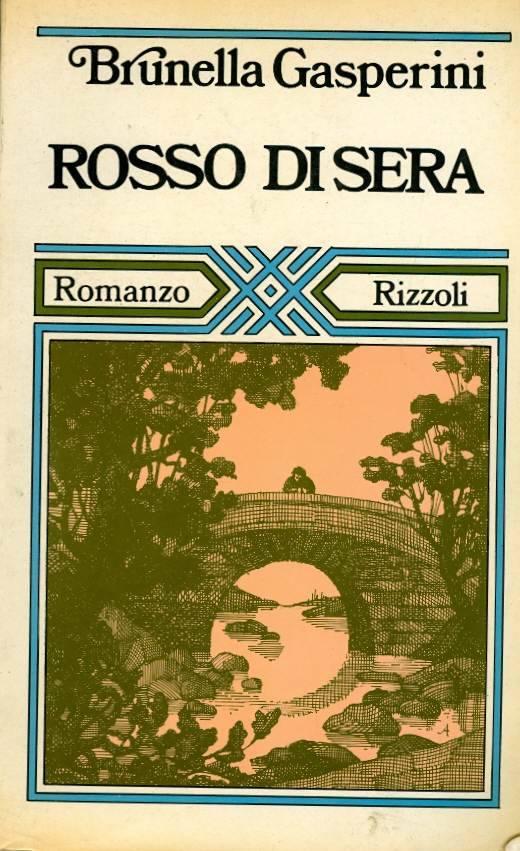 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Brunella Gasperini fu grande giornalista, di costume, di vita, di maniere gentili. Esplose nel 1963 alla scrittura narrativa proprio con “Rosso di sera” (Rizzoli), romanzo adolescenziale (ma definizione limitante) e di formazione, che suscitò non poco clamore nell’Italia agli esordi del boom economico. La storia che Brunella Gasperini ebbe il coraggio di presentare rompeva omertà e ipocrisie di una società oramai verso il collasso. I personaggi migliori sono il nonno anarchico e anticonformista, allontanato ed esiliato dal resto della famiglia borghese e bigotta (“Gli altri, mio padre, mia madre e i grandi in genere, ti parlano come se l’esser giovani fosse una colpa, o una buffa malattia, o almeno un transitorio accidente. Il nonno, solo guardandoti, ti rende cara la tua giovinezza, perfino nel momento in cui ti fa star male”); la donna abbandonata e sola, che cerca di combattere per la salvezza di sua figlia, una ragazza turbata e depressa, con una vita e una personalità decisamente borderline. Nel romanzo non si ha certo paura né tremori a evidenziare questi caratteri, queste alternative scelte. C’è già, in germe, la voglia della ribellione che poi esploderà di lì a pochi anni, con una contestazione che si farà ben più violenta ma spinta dalle medesime esigenze che compaiono in questa emozionante storia, narrata come una fiaba, come un sogno lungo una vita.
In Rosso, il ragazzo protagonista, c’è l’ansia di diventar grande ma non la fretta di crescere. C’è una maturità in doloroso e tumultuoso allestimento. C’è il primo incontro con l’amore: con una passione che, seppure vissuta da due adolescenti, non è sbadata né sbandata; ma è un amore covato con l’attenzione di cercatori d’oro, con sacerdoti che cercando di preservare una parte fragilissima di bellezza. E la passione d’amore, in Rosso, si unisce e si allaccia indissolubilmente all’amore per le poesie. Soprattutto quelle di un grande Pablo Neruda, tanto amato anche dal nonno anarchico. Ma ci sono anche altri poeti e poetesse, da Saffo a Sergio Solmi. Questo romanzo, nonostante gli anni siano trascorsi, non ha niente a che vedere con gli stanchi, sfibrati, banali, ipertrofici, volgari volgarissimi amori odierni di quattordicenni e quindicenni che confondono amore con altro e ignorano ogni possibile ricchezza di vera letteratura.
È una passione scriteriata, quella che Rosso nutre per letteratura e amore; un’ansia, un bisogno intimo e costante, quello della poesia. Che a sua volta si unisce a un amore (ritenuto persino inutile, dall’altra società) della musica: Rosso suona la tromba come fosse un arma, una bacchetta magica che lo può separare da tutte le volgarità, dallo sconforto, dal dolore. E, inevitabilmente congiunto con l’amore, c’è l’incontro con le prime delusioni, le prime frustrazioni, la sconfortante ansia delle ore che incalzano e che non sembrano mai dare requie. C’è il rimorso, un sentimento fin troppo adulto: così, infatti, Rosso si incolpa di non aver saputo fare altro che regalare alla sua amata “soltanto della letteratura”. E anche quando sembra che tutto non possa far a meno di ripiombare nei canoni consueti della società, immobilizzarsi di nuovo in quel mutismo, in quel borghese perbenismo soffocante, quando non sembrano praticabili altre strade che quelle della carriera benestante (maturità, università, fidanzata, matrimonio, figli…) la ribellione giunge, viene gridata senza voce; Rosso chiude il racconto della sua storia con una frase che diventa manifesto e programma: “No, non voglio dimenticare”.
Oriana Fallaci intervista la storia.
 Dalila Sansone
Dalila Sansone
AREZZO – Lei, l’autrice Oriana Fallaci, lo definiva un testo al limite tra la storia e il giornalismo e nella prefazione (che vale la lettura) avvisa il lettore: non farsi sfuggire la realtà dei fatti, sottrarsi all’equivoco del conflitto ideologico tra potere e anti-potere. Lo scontro è tra uomini, che scelgono l’una o l’altra parte. Uomini, soltanto questo.
Quello che lei tace è quanto diversa possa essere l’accezione della parola UOMO, ne esclude la definizione e lascia che siano le parole degli intervistati a stratificarne il senso, tranne in chiusura quando a uno di loro lo domanda : Alekos, cosa significa essere un uomo?
Intervista con la storia (Rizzoli, 1974) è una raccolta di diciotto interviste a personaggi di potere (in prevalenza) e di ferma opposizione alle prevaricazioni, raccolte tra la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ’70. Interviste che sbalordiscono per efficacia, capacità di sintesi, spaziatura geografica e ideologico-culturale. La lettura dispiega il personaggio storico, privato, umano o inumano, condensandolo in una successione stringente di domande e risposte, mai superflue o retoriche le prime, maledettamente rivelatrici pur nella menzogna le seconde. La Fallaci fa precedere ogni intervista da un breve ritratto del personaggio, in cui descrive le circostanze dell’intervista, l’impatto della pubblicazione e in cui non rinuncia a fornire l’impressione sulla donna e non sulla giornalista. Nell’epoca di una comunicazione troppo immediata e poco filtrata, le pagine scorrono e gravano di un fardello etico e intellettuale, quasi sacro, il trittico intervistatrice – intervistato – lettore. Soprattutto il lettore. Egli non può esimersi dall’esercizio critico e dal formulare un proprio giudizio. Intervista con la storia, era un libro a cavallo tra storia e giornalismo, è invece adesso un testo la cui attualità sta nella testimonianza, intanto, di una “storia che si scrive nel suo divenire e di cui si è testimoni” e soprattutto di un’etica del giornalismo e della verità, finite sempre più diluite dagli slogan, dalle notizie ad effetto e dalle illusorie forme di accesso all’informazione. La chiave di volta nell’interpretare il destino degli uomini rimane, in qualunque circostanza, l’analisi chirurgica dei fatti e la loro lettura alla luce dell’indole umana, quella dei potenti e dei popoli, quella intrisa di rassegnazione o di riscatto. E’ necessario che per poterli leggere i fatti, qualcuno si assuma il compito di cercali e metterne insieme tutte le parti, evitando omissioni o facili soluzioni, ripudiando la retorica e odiose ipocrisie.
Per chi, come chi scrive, non era ancora nato quando Oriana Fallaci girava il mondo per ottenere qualche ora di tempo dai protagonisti delle sue interviste e finire sulle liste nere di molti , la lettura di questo libro è un riassunto di passaggi epocali della storia recente, restituiti con l’immediatezza di un’istantanea a due facce, quella di chi osserva e quella di chi determina.
Il continuum che procede dalla fredda figura di un Kissinger decisore delle sorti del mondo e dalla voce incapace di modificare la posizione dell’ago del magnetofono, alla passione libertaria e solitaria di Alekos Panagulis, è una successione di umanità che in comune ha solo una indeterminata complessità, un impasto di destino o occasione e di individualità, che si chiude con la citazione di una poesia. Con la definizione di UOMO sintetizzata in quella poesia. L’intero volume a questo punto è retrospettiva: alla scala di valori di ciascuno trovare la propria visione delle responsabilità dei singoli, individuali e collettive, giacché il confine è estremamente labile.
“Paula”, un modo per dirsi addio.
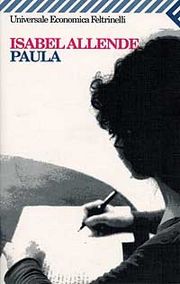 Dalila Sansone
Dalila Sansone
AREZZO – Ci sono molti modi di dire addio. E molti modi per riuscire a pronunciare la parola addio, accettarla. “Paula” (1994) è il difficilissimo percorso del più complicato degli addii: quello di una madre alla figlia. E’ la prova più impegnativa di Isabel Allende, già scrittrice di successo e testimone di avvenimenti enormi, capaci di schiacciare la vita di uomo. Invece non è vero, a tutto si sopravvive, abbandoni, povertà, colpi di stato, atrocità ma solo di fronte alla perdita imminente tutto vacilla e perde di senso. Nasce come àncora nel corridoio dei passi perduti, l’anticamera della terapia intensiva di un ospedale di Madrid, questo libro. Una lettera per Paula perché al risveglio dal coma improvviso, causato da una malattia rarissima, recuperi spigoli, angoli e lunghe curve dei momenti di vita assente e trascorsa. Lentamente la lettera diventa racconto, secondo una tradizione consolidata delle donne di famiglia, quella di raccontarsi l’una all’altra da lontano, attraverso lettere da conservare gelosamente. Il bisogno di scrivere per non andare alla deriva, l’ansia di comunicare con la figlia vicina eppure distante, si intrecciano e si trasformano in una sorta di memorie della vita e dei romanzi di Isabel, intrecciate alle sorti di un Paese lontano, il Cile, e di un continente devastato dal passo imperante del lato truce della storia, quella dalla “S” maiuscola.
Paula non si risveglierà da quel lungo sonno. Sua madre riesce a maturare l’addio cercando nella scrittura la forza necessaria a separarsi da lei. Al bisogno fisico di combattere al posto di Paula per non cedere alla rassegnazione, subentra, col passo lento del dolore che matura, la consapevolezza della direzione di questo percorso. Dall’ospedale di Madrid, senza accenni di cambiamento del suo stato, Paula torna a casa, il luogo degli affetti privati, dall’altra parte dell’oceano. Resta sospesa nella stessa stanza dove con la stessa partecipazione e lo stesso amore con cui aveva preso parte alla nascita della nipote, Isabel lascerà andare via poi sua figlia.
Quando la tragedia, qualunque essa sia, assume la connotazione della dimensione personale e privata, induce sempre una misteriosa empatia, anche quando i particolari non trovano nessuna rispondenza nelle vite di chi osserva o chi legge. Quella parentesi di esistenza ha i tratti di una figura completamente nuda e fragile, in cui i difetti e debolezze dominano incontrastate e dove la linearità scompare fagocitata dal disordine interiore. Il mondo, umano e magico nelle stesso tempo, della narrativa della Allende rivive di nomi e accadimenti di vita vissuta e proprio questa commistione di umano e magico si scopre lo strumento, personalissimo, attraverso cui accettare l’addio. E’ una religione laica quella di Isabel, costruita sulla passione per la vita e il bisogno di lasciarsi travolgere dalle emozioni fino a vivere attraverso di esse, negando la possibilità che si possa, al contrario, vivere dominandole. Una religione ”umana” che riconosce il potere sovrannaturale dei legami, e di quelle circostanze inspiegabili, quasi magiche, che spesso accadono e che bisogna solo essere capaci di vedere. Non serve a nessuno dimostrare che si tratti di pura suggestione. Non ha alcuna importanza, in nome del diritto di ciascuno a trovare il proprio unico modo di scandire la più definitiva delle parole. L’accettazione interiore diventa liberazione dal volto angosciante del dolore: rimane il vuoto, col quale solo l’amore provato e ricambiato consente di convivere. Ed è proprio allora che anche Paula si arrende, lasciando questa verità in eredità a colei che, dandole la vita, per prima l’aveva iniziata al potere assoluto dell’amore.
L’alta letteratura del “Viaggio al termine della notte”
 Dalila Sansone
Dalila Sansone
AREZZO – L’ossessione è il tema ricorrente, un’ombra pesante nascosta nelle pieghe del racconto. Louis-Ferdinand Céline è spietato. È lui in prima persona ad esserlo, lo sono i suoi personaggi, i luoghi, il clima, la storia. Perché l’ossessione? Perché non può esserci altra spiegazione al tormento di Bardamu, al suo incessante non fermarsi mai, non fermare mai la discesa negli inferi del cinismo, nella bassezza dell’umano. Non è facile Céline, non lo è affatto! Tralasciando gli aspetti propriamente letterari o linguistici, “Viaggio al termine della notte” (1932) è oggettivamente perfetto nell’essere quello che è e, allo stesso tempo, il suo contrario. Apparentemente non c’è un briciolo di sentimento eppure proprio la negazione dell’umano è prepotente nell’affermare il suo opposto, accennato nei lineamenti appena abbozzati di personaggi che hanno provato ad esserlo, umani, ma che sono finiti poi annegati nelle circostanze o sono stati abbandonati alle loro vite, vite che non potevano scivolare troppo a lungo accanto a quella di un giovane irrequieto, dapprima ingenuamente teso verso ideali sconosciuti (è il caso di dirlo) e poi alla continua deriva. Sarebbe riduttivo vivisezionare con intenti psicologici il lungo percorso dall’arruolamento impulsivo nell’imperversare della prima guerra mondiale, attraverso la diserzione/malattia, la fuga in Africa, lo sbarco in America, fino alla carriera di medico di periferia. Sta tutta lì dentro, in quel coacervo di (semi)vita, l’ossessione: ossessione per l’abiezione, la propria e di riflesso di tutto il resto. E’ vibrante il senso continuo di disagio per una condizione talmente naturale da apparire inevitabile quanto asfissiante. Se si sta annegando o perdendo completamente in qualcosa, l’unica necessità avvertibile è l’ossigeno che manca, la direzione che si è persa, eppure la volontà si scopre troppo debole per cercare sia l’uno che l’altra. Si sfinisce in una sorta di accidia latente, fisicamente ingombrante, quasi fosse un personaggio in carne ed ossa. In una spirale perversa ciò crea disgusto e spinge sempre indietro. Così l’alter ego di Céline non può che andare fino in fondo, al termine dell’oscurità e scoprire che non gli è rimasto niente del senso comune dell’essere uomo; scoprire di averlo sempre saputo che uomo non lo era mai veramente stato.
È una realtà tetra, gelata dal vuoto di umanità, offuscata dalla nebbia, dominata da scorci di vie notturne, quella che si materializza tra le righe. Lo sfondo perfetto, lo stesso con tratti diversi ma ovunque sistematicamente uguale. Nessuna distrazione, lo sguardo non si alza mai oltre il confine dei muri, lo scorrere delle strade e sulle strade e non c’è niente e nessuno in grado di salvarlo, semplicemente perché la salvezza non esiste. Solo la notte dell’anima esiste, da percorrere fino in fondo, ancora più in fondo di quanto si possa credere.
Che si ami o si disprezzi questo libro ha una classificazione inequivocabile: letteratura. Alta.
“Guida teorico-pratica per soli uomini all’uso del ferro da stiro”: 1992, quando gli uomini volevano ancora stirare
 Giulia Siena
Giulia Siena
ROMA – “Per prima cosa, restate calmi: il ferro da stiro è uno strumento. Appartiene alla stessa categoria di oggetti di cui fanno parte un trapano o una morsa. Magari lo considerate un lampante emblema di femminilità, la prova tangibile che siete un povero castrato, ma allora forse siete anche quel genere di uomo che giudica la caccia con l’arco un passatempo da femminucce”. Il ferro da stiro è solo un attrezzo, un oggetto di metallo creato per facilitare la vita di chi stira; tra questi ci sono anche gli uomini. A loro, soprattutto a loro, forse solamente a loro (ma utile anche per noi donne), è dedicata la “Guida teorico-pratica per soli uomini all’uso del ferro da stiro”. Pubblicato nel 1992 da Longanesi, questo piccolo e interessante opuscolo di E. Todd Williams è – come dice il titolo – una spassosissima guida all’utilizzo del ferro da stiro. Questo amico/nemico delle massaie viene visto dai maschi della specie umana come una fumante minaccia alla propria virilità: stirare non è da veri uomini, ma le camicie si indossano necessariamente senza pieghe!
Allora, cari uomini, smettete di piagnucolare e guardate in faccia la realtà: dovete stirare e nessuno vi aiuta, nessuno lo farò al posto vostro. Dovete – esorta l’autore – rimboccarvi le maniche e imparare ad andare su è giù sull’asse da stiro con un aggeggio ferroso e spesso ingrato a disinnescare e appianare solchi dovuti al lavaggio. Ma non tutto è perduto; il libro dispensa alcuni piccoli accorgimenti da tenere a mente per venirne a capo: 1. non trovate scuse, dovrete farlo voi; 2. scegliete le camicie giuste (tutti sanno che il lino è il peggior tessuto da stirare); 3. istruitevi sul vostro nemico ferro da stiro, spesso ha anche alcuni pregi; 4. capite come lavare e asciugare, vi faciliterà il lavoro; ora comincia il bello… imparare a stirare! Dalla teoria si passa alla pratica, dallo scetticismo alla determinazione per portare a casa (e tenere a casa!) il risultato.
Un libro divertente, pratico e geniale; un testo ironico e immediato che purtroppo è tra le pubblicazioni fuori catalogo, un vintage da accaparrarsi al volo.
“Valdostani. Guida ai migliori difetti e alle peggiori virtù”.
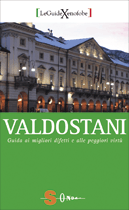 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Le guide non servono solamente per conoscere i luoghi né per scovare le bellezze da non perdere. Le guide servono anche per capire gli abitanti. E probabilmente sono, per questo, anche più utili. Le Edizioni Sonda l’avevano intuito: a loro il merito di aver pubblicato una serie di guide, nella collana “Le Guide Xenofobe”, alle varie popolazioni italiane, dai torinesi ai cuneesi ai triestini ai fiorentini. E ai valdostani, il cui ritratto fu affidato a due che valdostani lo sono per ‘adozione’: Vincenzo Calì e Giulio Cappa. I due giornalisti idearono “Valdostani. Guida ai migliori difetti e alle peggiori virtù” nel 1997, ma quasi dieci anni dopo, nel 2006, l’editore chiese una revisione del materiale, per adeguarlo al passare degli anni e ai cambiamenti socio-culturali. Il giudizio dei giornalisti fu comunque impietoso, né si attualizzò molto: “Pensare i valdostani come un popolo che si trasforma negli anni significa decretarne la fine. La cultura valdostana è definita una volta per tutte, e non si può toccare senza minacciarne la purezza”.
Il titolo della guida è ampiamente esplicativo del suo contenuto: la Valle d’Aosta e i valdostani sono descritti impietosamente, con un’ironia e un’arguzia profonde e calibrate, ma mai offensive né volgari. Si prendono di mira i luoghi comuni, le immagini che automaticamente vengono in mente non appena si sente nominare Aosta e la sua Valle: dalla fontina alla grolla, dalla Fiera di Sant’Orso ai monti più alti d’Europa (anche se i valdostani “con sottile inquietudine attendono il momento in cui le cime degli Urali verranno considerate Europa a tutti gli effetti”). Ne vengono svelati i difetti “migliori”, come il presunto utilizzo del francese, e le virtù “peggiori”, come un legame maniacale con la terra d’origine, anche in caso di trasferimento, in Francia nella maggior parte dei casi (particolarmente divertente il capitolo dedicato a “Quelli che ritornano”, ovvero gli émigrés). Soprattutto se ne prende di mira il loro attaccamento morboso alla welfare Region, ossia alla Mamma Regione, che in virtù dello statuto speciale (la prima regione italiana a vederselo riconosciuto, nel 1946), dispensa e compensa agevolazioni e contributi per ogni genere di necessità: “Nessun aspetto della vita dei valdostani è trascurato”. Anche se adesso, in tempi di crisi, sarebbe meglio correggere con un imperfetto. E poi si analizza la popolazione (“La Valle d’Aosta è piena di calabresi, arrivati a ondate successive a partire dagli anni Quaranta”), il turismo, le bataille des reines, il Casino de la Vallée e la Carte Vallée (oramai passata testimonianza dei buoni benzina). La parte politica è quella decisamente più sfiziosa e divertente, dove i due giornalisti analizzano soprattutto il prototipo valdostano, molto frequente, del “dipendente regionale”. Scritto con uno stile divertente e divertito, il testo colpisce soprattutto chi si avvicina, dall’estero, a questa regione tutta particolare, per la sagacia penetrante e la lucidità sorprendente. Tra un sorriso e una risata soffocata, si riflette e si medita su quanto di naturale e genuino ma anche di contraddittorio e assurdo sopravviva ancora in questa piccola piega di mondo, dove gli abitanti sono appena 127.000 e i consiglieri regionali ben 35.
“Lettere da Sodoma”, dove l’amore è feroce.
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – “Un reietto, un rifiuto della società costituita, un borghese che è sceso fino al rango fangoso dei pezzenti, dei falliti”. Fallito, soprattutto, nelle sue ispirazioni artistiche e poetiche. È questo il personaggio protagonista del romanzo epistolare “Lettere da Sodoma”, che Dario Bellezza pubblicò per Garzanti nel 1972. Attraverso missive inviate a scontornati destinatari, Marco narra la storia della sua condizione, di questo strazio di vivere che si tesse con un più profondo supplizio d’amore: “Ho orrore della mia condizione di maniacalmente depresso che desidera l’orrore dell’euforia: fra questi due poli oscilla la mia vita”. E la sua vita è una continua lamentazione, un inarrestabile cadere in spazi d’ombra interiori, dove tiranneggia “la tragicità fanatica del quotidiano”. È un continuo ripensare ai suoi fallimenti, affliggersi con legami sadici e furenti: “Vivere di progetti non mi basta più”, ma neanche il sogno ha più spazio nella sua vita, neanche un amore che sia sano e maturo, puro e coraggioso.
Il tiranno per eccellenza, che spadroneggia e infuria, è Luciano, un ragazzino che si prostituisce per capriccio e avidità, che si diverte in un gioco perverso a tormentare e torturare il fragilissimo amante. La soluzione, Marco, l’ha ben chiara: “Mi ripeto che per farlo stare con me lo devo fare mio prigioniero”. È un amore cannibale, un amore tormentoso, una continua violenta prevaricazione e . Le parole di Marco sono velenose frecce, affondi feroci e violenti, ma anche consapevole che l’altro abbia un’armatura resistente e tenace, possegga una capacità innata di difendersi semplicemente con il potere della sua esistenza svagata e indisciplinata: “Lo scandalo di questa solitudine in cui mi costringi mi ucciderà. Attenta al rimorso. Ma tu sei troppo superiore a tutto”.
Marco sceglie la lettera, una forma di lettera poetica, per indagare il proprio scontento e lanciare anatemi e violente requisitorie contro i suoi amici, i suoi amanti, i suoi nemici, i suoi amori tribolati; la lettera gli dà compagnia, gli concede la possibilità di fingere una sciarada, una ricostruzione aleatoria e fittizia di una vita che lui desidererebbe intensamente non fosse la sua: “Ecco perché almeno queste lettere mi fanno un po’ di compagnia: sorelle della mia futura morte. Sono la mia ultima occasione, dove, niente essendo autobiografico, tutto lo sembrerà, senza rimedio”. Ma la lettera è strumento di strenua difesa, l’unica possibilità – fallito il tentativo letterario – per significare il suo io più profondo e concedersi una giustificazione d’esistenza: “Sono attaccato a queste lettere come un naufrago alla sua zattera che forse lo porterà a salvazione. Soprattutto le scrivo per uccidere il tempo, la noia”. La sua è una confessione, un tentativo di espiazione (“Mi sto laicamente confessando”). Ma abita a Sodoma, e pare non esistere per lui nessuna promessa di redenzione.
“Qual è il mio posto in quest’ordine?”
 Michael Dialley
Michael Dialley
AOSTA – Un baule, una stanza: questi i due luoghi dove Momo, africano inventato da Tahar Ben Jelloun in “Le pareti della solitudine” (edito da Einaudi nel 1997 ma scritto dall’autore nel 1976), nel quale l’autore s’identifica, vive completamente abbandonato a se stesso in una Francia razzista della metà del XX secolo. È una narrazione molto poetica, parti in versi e parti che sembrano un quadro tante sono le immagini visive che si creano nel lettore.
Questa poesia, comunque, non è casuale: come afferma Ben Jelloun, “soltanto la poesia, solo la finzione letteraria può essere in grado di dire e di far vedere e capire un uomo che soffre nel cuore, nel corpo, nella vita”.
Leggendo ci si rende davvero conto di quanto difficile e triste sia la storia di questi uomini; Momo dà voce a tutti loro, creando quadri, con le parole, dalle pennellate vigorose, potenti, cercando di richiamare il calore del sole, i colori e le tinte più vive; cercando, soprattutto attraverso i suoi sogni, di ricordare e far rivivere i sorrisi e la felicità tipici di questi popoli, dotati di una grande ricchezza interiore, smarrita dagli occidentali, ma che purtroppo viene totalmente ignorata e cancellata dalle violenze e dalle ostilità.
Costretti alla schiavitù, ad accettare condizioni di vita pessime, contratti che fanno rabbrividire tante sono le regole senza senso che travalicano e calpestano ogni singolo diritto umano (non si può nemmeno morire nelle stanze che vengono concesse a queste persone!).
Paradossalmente, però, più vengono sottomessi, più questi uomini sognano e sentono accrescere la voglia d’integrazione: Momo cerca di mescolarsi tra la folla, perché vuole “far parte di quella folla”, desidera “di esistere diversamente da un calzino bucato”.
Tanta sofferenza, fatica, tante rinunce, ma per cosa? Momo lo dice molto chiaramente: “Sono venuto nel tuo paese con il cuore in mano, espulso dal mio, un po’ volontariamente e molto per bisogno. Sono venuto, siamo venuti per guadagnarci da vivere, per salvaguardare la nostra morte, guadagnare il futuro dei nostri figli”.
Una grande solitudine vive nelle pareti di questi “bauli”, ma soprattutto nei corpi, nei cuori e nelle anime spente di questi uomini che rinunciano a tutto e tutti per il loro futuro e quello dei loro discendenti.






