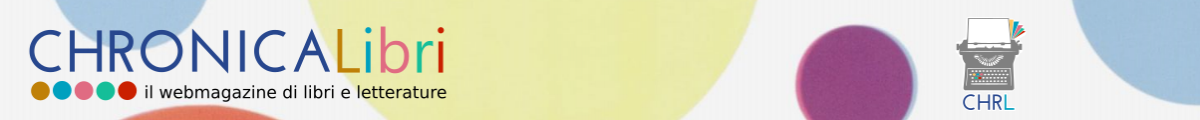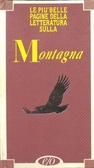Giulio Gasperini
ROMA – La montagna è stata, nella letteratura italiana, una presenza costante ma silenziosa, dimessa, rispetto al più chiassoso, ipertrofico e tiranno mare. Più umile la montagna, più apparentemente remissiva. Come lo è nella realtà. In superficie calma, mai rumorosa, piuttosto refrattaria alle mode e agli eccessi. Sicché ecco la sorpresa nello scovare raffinate pagine della letteratura che hanno lei come protagonista, o come privilegiato scenario di vicende che spaziano dalla scalata sportiva all’indagine delle prospettive intime del sé. Le edizioni e/o raccolsero, nel 1992, un florilegio de “Le più belle pagine della letteratura sulla montagna”, perché la montagna, più del mare e di altri paesaggi antropici e naturali, è mutevole, vivace, briosa; e spinge al pensiero e alla meditazione.
Categoria: Letture vintage
Vita romana- un tuffo nel quotidiano dei sette colli
Marianna Abbate
ROMA – Roma è un bel posto. Ve l’assicuro, e ve lo ho anche dimostrato in un’antica recensione di un’insolita guida romana. Ma in questo periodo autunnale, con l’arrivo del fresco e del profumo di castagne mi è venuta un po’ di nostalgia. Ho riesumato dalla libreria del mio fidanzato un vecchio libro di buon gossip storico, e carteggiando ho ripercorso i momenti salienti della sua gloriosa storia. Il testo in questione è “Vita romana” di Ugo Enrico Paoli pubblicato nella collana Oscar Saggi Mondadori. Continua
“La mia fuga dai Piombi”: quando Casanova, grazie alla cultura, evase.
Giulio Gasperini
ROMA – Giacomo Casanova fu, insieme a Cagliostro e Lorenzo da Ponte, il personaggio che più animò, sapidamente, le cronache mondane e sociali dell’Europa del Settecento. In quella che Benedetta Craveri ha definito “la civiltà della conversazione” esistevano salotti dove il chiacchiericcio era l’occupazione principale, dove le signore e i signori, senza vergogne né pudori, si raccontavano le notizie e le dicerie, gli scandali e i tradimenti, riportavano le conversazioni ed esageravano i sospetti. Possiamo soltanto immaginare quanto la personalità di Casanova, anche in seguito alla pubblicazione del racconto della sua evasione dal carcere più inespugnabile del mondo (“Histoire de ma fuite des prisons de la République de Venise qu’on appelle ‘Les Plombs’”, pubblicata in francese nel 1787) facesse congetturare e divertire.
"Libro di Ipazia": in un mondo che cambia chi sa distinguere il tramonto dall’alba?
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
ROMA – La verità più profonda è quella che pronuncia Sinesio: ha il sapore (l’ombreggiatura) d’una profezia che, a distanza di secoli, si sta compiendo anche nei nostri miserrimi anni Zero: “Quando si è in alto mare la luce del tramonto e quella dell’aurora non sono molto dissimili. Non so bene distinguere”. Come a voler dire che, in epoca di transizioni, quella che pare la fine potrebbe essere l’epilogo ma potrebbe ben essere pure l’inizio di qualcosa d’altro. Ed è proprio questa indecisione, questo dubbio feroce, che Mario Luzi ha voluto indagare, in questa sua raffinata opera, “Libro di Ipazia”, edita da Mondadori nel 1978.
Ipazia è donna combattiva, che non depone l’unica arma a sua disposizione – la parola, ovviamente – per esortare e convincere i suoi concittadini a non lasciarsi travolgere da un cambiamento incombente e preoccupante, inquietante. Ipazia sfida le folle cieche di violenza e sprezzanti del ragionamento, impavida sa che l’ora è compiuta e che i sofismi non son più validi: adesso c’è solo da impugnare il proprio volere e conquistare il rispetto di sé.
Ipazia si immola, su un prevedibile altare: verrà assaltata dalla folla e smembrata al centro di una Chiesa, come fosse un novello Cristo pagano. Lei difendeva la cultura ellenistica, erede legittima della cultura classica, in una città, Alessandria, che rinnegava il suo passato vivace e stimolante per soccombere a ondate di invasioni, più o meno pacifiche (“Ah città morente, città crepata nelle fondamenta, come ti divincoli nell’agonia credendoti viva”): prima la religione cristiana, che si edifica su quella classica, e poi i barbari, che distruggono e poco ricostruiscono (“Dappertutto c’è divisione: tra ciò che si muove e ciò che sta, tra ciò che si disgrega e corre verso la gola spalancata e buia del futuro e ciò che si aggrappa alle macerie per resistere”).
Ogni epoca ha i suoi cambiamenti, e ogni cambiamento fa paura, scuote le coscienze, allunga le ombre dell’inquietudine e dell’apprensione (“Non ci sono leggi che impediscano e neppure leggi che proteggano. Non ci sono leggi affatto. C’è solo chi fa la legge”). Dove porterà la mutazione, dove sarà l’approdo per una nuova rotta che non conosce nocchiere né stella a orientare?
Mario Luzi è un cesellatore del ragionamento, è un attento collezionista della parola. Non c’è un solo termine che non sia giustificato, non c’è un solo ragionamento che abbia un cedimento. Non c’è un solo personaggio che dica più del necessario, più di quello che è consentito dalla storia, dalla geografia, dalla religione.
C’è poi chi, come Sinesio, vive la conflittualità d’una vita precedente rinnegata e d’una nuova abbracciata senza troppa convinzione: dove andare? Che fare? Quale deviazione prendere? (“Lo stato delle cose muta e mutano i nostri giudizi sinceramente talvolta, più spesso per necessità”). Domande antiche, remote; ma che, a ogni crisi, si ripropongono e, per questo, sono sempre fin troppo attuali.
"Gentilissimo sig. Dottore, questa è la mia vita": un volto per tutti quelli che non disturbano la Storia.
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
ROMA – Sono molte le latitanze per non disturbare la Storia: Elsa Morante, ad esempio, lo dimostrò e documentò magistralmente in quel capolavoro che intitolò, non casualmente, “La Storia”. Negli anni del ribattezzato “secolo breve” uno dei modi coatti, più vergognosi e turpi, nel quale violare e sacrificare le individualità, fu il manicomio. Tutto questo prima della legge 180/78, la legge Basaglia, che chiuse tali “istituti” col nobile proposito (ahimè, mai perseguito né realizzato) di accudire e seguire i presunti “malati” in altri contesti e in altre forme di socialità. Poche sono state le voci che, dall’inferno di codesti istituti, si sono sollevate e sono giunte a ripristinare e riconfermare una liricità d’esistenza, una fiera (e, in molti casi, lucida) cognizione del sé. Adalgisa Conti è una di queste voci: sua è una lettera, di spietato autobiografismo, datata 25 marzo 1914, e pubblicata nel 1978 da Gabriele Mazzotta Editore, che si apre con queste limpide parole: “Gentilissimo sig. Dottore, questa è la mia vita”.
Quasi sempre, infatti, i documenti che han riportato in vita quest’umanità dolente, questi uomini e donne di dolore, sono lettere, ritrovate un po’ per caso un po’ per sbaglio nei mucchi di materiale e di documentazione studiato, con coraggio e passione, spesso solamente da associazioni interessate a un recupero memoriale che non fosse solamente pura curiosità morbosa, ma consapevole resurrezione e redenzione di coscienze (le nostre, prima che le loro). Lettere che testimoniano quanto la scrittura fosse sentita dai “pazienti” come mezzo per preservare intatta la propria vita.
Un privilegio, quello di essere “alfabeta”, che pure Adalgisa scontò come una punizione, cercando di trovare nelle parole il suo affrancamento: dalla stesura della lettera, infatti, appena internata, trascorsero più di sessant’anni, nei quali Adalgisa tornò a essere di nuovo una lunga lista di appunti su una cartella clinica (e quasi tutti che la indicavano come “invariata”).
La vicenda di Adalgisa Conti è simile a quella di molti altri uomini e donne, i quali, come è scritto nell’Ecclesiastico, “svanirono come se non fossero esistiti; furono come se non fossero mai stati”. Molti, nelle loro lettere, chiedevano ai familiari di andare a trovarli, perché non riuscivano a capire la ragione della loro segregazione, della loro esclusione dal mondo.
Simone Cristicchi ci ha presentato, nel suo album “Dall’altra parte del cancello”, un certo Gottardo, che scrisse alla moglie, dal manicomio di Volterra: “È già diverso tempo che io mi trovo in questo manicomio ricoverato […] Non potete immaginare quanto brami di tornare a Cecina, che qui mi par d’essere in esilio”. La giovane Adalgisa, invece, chiese alla madre: “Devo aver fatto dei gran mali al mondo non è vero mamma?”; con uno sbigottimento che spezza il cuore.
Le "parole in un orecchio" di Genuzio Bentini
"Anna dai capelli rossi" irrefrenabile sacerdotessa della fantasia
Marianna Abbate
ROMA – Certe volte vivere un’infanzia senza televisione può avere i suoi vantaggi. Non dico che l’infante si renda immediatamente conto dei benefici, ma è innegabile che il tempo guadagnato/rubato alla tv può essere sicuramente ben impiegato. Io, ad esempio, ho usato innumerevoli ore che gli altri hanno dedicato a Sailor Moon (con mia immensa invidia) nel leggere e rileggere la bellissima saga di “Anna dai capelli rossi” di Lucy Maud Montgomery, che molti di voi sicuramente conoscono dall’omonimo cartone animato. Ebbene il libro (o meglio: i libri) sono infinitamente migliori e ora vi spiego perchè.
Se ben ricordate la dote principale di Anna era la fantasia. Le mille storie che inventava per abbellire le sue origini di orfanella, i cavalieri fatati e gli spiriti del bosco sono tutti frutto della fantasia. Una fantasia esuberante e mai doma, che l’ha spesso portata a cacciarsi nei guai, ma che le ha permesso di vedere il mondo con occhi sognanti e innamorarsi ogni giorno di una farfalla.
Ora, non prendete le mie parole per collosa melassa, ma la fantasia si può sviluppare in un solo modo: con la lettura. Le farfalle, i boschi, le fate sono molto più belle nella nostra mente di quanto non lo possano essere sullo schermo. Persino le streghe sono più originali nei nostri pensieri di quelle uniformate che ci capita di guardare nei film. Quando leggiamo vediamo il mondo con i nostri occhi e non con quelli di un regista, limitato dalla propria fantasia e dalle conquiste della tecnologia. Nella nostra mente il 3d esiste da sempre!
E’ questo che Anna di Colleverde ci insegna ancora oggi: di chiudere gli occhi e guardare col cuore.
Pertanto nei caldi pomeriggi di Agosto, quando i vostri figli non possono uscire per via del sole rovente, spegnete la tv e nascondete il telecomando. Trovate nelle vostre librerie i vecchi libri per ragazzi e guardateli, mentre il mondo fatato delle mille storie li trascina con sé.
E nel frattempo trovatevi anche voi qualcosa di interessante da leggere, meglio se dalla copiosa vetrina di chronicalibri.
"10 Libri dell’estate Vintage"
G.o G.a
ROMA – Cercare in un libro una scrittura che difficilmente si trova tra le novità in libreria. Storie che abbiamo cercato nella Letteratura del Novecento e che oggi vi suggeriamo per la vostra estate: 10 Libri dell’estate Vintage.
1. Estate, di Elio Pecora
2. Lettere da Capri, di Mario Soldati,
3. Le strade di polvere, Rosetta Loy
4. Storia dela mia fuga dai Piombi, di Casanova
5. L’amore negato, di Maria Messina
6. Il prete bello, di Goffredo Parise
7. La sparviera, di Gianna Manzini
8. Troppo tardi, di Carlo Cassola
9. Il campiello sommerso, di Nantas Salvalaggio
10. Ballata levantina, di Fausta Cialente.