 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Ci siamo conosciuti a un delizioso festival, Babel, che qui ad Aosta si tiene tra fine aprile e inizio maggio. Andai alla presentazione del suo libro, una raccolta di racconti intitolata “L’appartamento e altri racconti” (edito dalla END Edizioni) e le proposi un’intervista. Anzi, una chiacchierata. E così è stato. Quella che ho cercato di riprodurre è proprio una conversazione, tra una cedrata e una tazza di tè, che ci siamo concessi, per più di tre ore, ai tavoli del “CAFé-librairie” di Aosta. In barba alla claustrofobicità dei monti, che tanti additano e accusano.
Alcuni dettagli di questi racconti mi hanno colpito; soprattutto le pagine che parlano più della contemporaneità. I racconti “Sexting” e “Thinspiration”, principalmente, sono molto interessanti anche perché io non avevo francamente idea che esistessero tali pratiche e non avevo mai letto un’analisi così attenta. “Sexting” m’ha colpito tantissimo: proprio anche questa terminologia inglese sparsa che dà proprio un’idea di freddezza. Questa ragazza che vive un comportamento come se fosse una cosa dovuta, quasi; senza neppure elaborarla in prima persona perché così va fatto, quella è l’impostazione che una determinata cultura ti dà. E questa terminologia secondo me lo scandisce molto bene, perché son tutti termini anche molto usati: termini tecnici che rendono ancora più asettico quello che viene compiuto.
Esatto, volevo proprio indicare questo iato tra la vita di questa ragazza qua, che sicuramente, come dici tu, mette in gioco valori che lei stessa non riconosce assolutamente. Questo racconto l’ho scritto per il concorso “Donne in opera” che quell’anno aveva come argomento “il corpo” e siccome io sono ossessionata dall’idea di essere originale, quando partecipo ai concorsi cerco sempre di declinare l’argomento nella maniera più originale possibile. Cerco, cioè, proprio la cosa che mi interessa ma che declino proprio nel modo che nessun’altra delle partecipanti fa. E mi piaceva quest’idea qua perché cercando in internet, sui blog e anche sui giornali erano uscite queste storie di ragazzine che vendevano le loro foto pornografiche via sms in cambio di ricariche di cellulare; dopo, intervistate o comunque sentite, dicevano: “Beh ma dov’è il problema, cioè che differenza c’è tra una mia foto e il calendario della Belen? Non c’è nessuna differenza proprio” e questa rappresenta una caduta dei valori: mi piaceva proprio l’idea di far parlare queste ragazzine in prima persona.
E infatti quello che a me ha colpito molto in tutti questi testi è proprio questa angoscia, questa sorta di irrimediabilità di un finale, questa accelerazione all’inevitabile, a quello che non è più scongiurabile.
Sì ma perchè io non posso scrivere di amore, non sono capace.
E quando scrivi d’amore, comunque, direbbe Gianna Nannini è “un amore cannibale”. Nel libro, però, l’amore da qualche parte c’è, tipo in “Ciò che ho di più importante” – una sorta di horror erotico -. Talmente cannibale da finire sottoterra. E anche in “Un dolce per te”…
Sì, quello è un po’ diverso perché lui è innamorato ma lei non lo segue. Più che altro nel primo, “L’appartamento”, c’è un amore particolare, in cui loro sono molto vicini e molto in sintonia…
Però è nel contesto di una società completamente disinteressata: l’appartamento lascia il vuoto nel palazzo e addirittura si richiede l’autorizzazione per quel buco, quel vuoto, e invece è ben più importante: è un’umanità che è sparita ed è andata chissà dove…
E continua a sparire: ad esempio, dall’altra parte del mondo ci sono tre coppie che spariscono di nuovo e magari spariscono anche altre perché nessuno se ne accorge. Questo è il paradosso. Perché a me piacciono comunque le storie che finiscono e fanno piangere. Io adoro Stephen King; mi è capitato di leggere un suo libro in cui i protagonisti alla fine si sposano, ma a me piacciono i finali che mi lasciano un po’ di angoscia dentro: li trovo più belli, più emotivi; mi emozionano di più rispetto a sapere che i protagonisti sono felici, perché forse la felicità, almeno da un punto di vista dei racconti, è limitante, e anche perché l’infelicità è una situazione dalla quale tu puoi uscire e puoi, poi, diventare felice. Tra l’altro, secondo me, un libro non finisce con l’ultima pagina: o il protagonista muore e allora lì è finito, è morto, però un libro, un racconto, mostra solo una parte della vita di un personaggio perché poi il personaggio dopo continua la sua vita anche se non è scritta, quindi io nella mia mente mi costruisco il suo futuro, me lo immagino.
Il genere del racconto si presta molto bene a questa scelta; offre un’opportunità maggiore, rispetto a un romanzo, di costruire più parti, più frammenti…
I finali che scrivo sono molto aperti. Lasciano al lettore la possibilità di prendere i dati che ho scritto e riutilizzarli immaginando quale possa essere il futuro. Alcuni miei amici si lamentano dei finali e mi dicono: “Tieni il lettore per mano e poi lo lasci lì”. È però questa una precisa mia scelta stilistica.
Funziona molto bene: questi son racconti costruiti con una pregevole accelerazione. Ad esempio, “Il ragno”. Impressionante proprio il fatto che quest’ansia claustrofobica nasce proprio dal quotidiano, dagli aspetti più rassicuranti.
Una delle paura più grandi, più irrazionali è di non essere al sicuro in posti dove dovremmo esserlo.
Che credo sia la paura in tempi come questi. La quotidianità dovrebbe essere la protezione più certa e sicura. La casa, ad esempio, è la cosa più quotidiana che abbiamo. Il nostro nido. Tutto lì dentro.
Io ho trovato veramente nella mia casa questo ragno che si dibatteva testardo. Quando ero piccola, mi divertivo a rompere sempre la sua ragnatela, ma avevo i sensi di colpa perché lui la rifaceva sempre. Ha ragione il ragno. L’istinto vince… esatto, e l’idea di questo ragno abbozzolato mi piaceva. Questo ragno che cresce mano a mano e non si sa bene cosa accada. C’è questo finale aperto, c’è il buio che non significa proprio la morte… eh sì, perché in questo caso lei rimane comunque tutta imbozzolata dentro la tela del ragno come se fosse morta. Non c’è luce, non c’è aria. Non dà subito l’idea istantanea della morte… No, più dell’angoscia, dell’agonia che chissà come poi si evolve.
Sono racconti che creano un’impressione appena finito di leggerli, un’impressione che dopo è difficile da cambiare. Analizzare troppo fa perdere molto del valore che hanno: è giusto che istinto rimanga. L’agghiacciante è proprio questo pericolo incombente del quotidiano: dal cucinare la torte, dalla farina sulle mani che apre uno scenario impressionante – anche perché non verosimile – però preoccupante.
Son racconti simbolici, perché il racconto sulle torte è un po’ splatter, preso da una situazione normale: un mio amico che fa torte, te le regala ma non le mangia mai con te. Lo trovavo triste e ho provato a crearci un racconto. Il protagonista è sotto ipnosi e non si rende conto di farle con ingredienti maledetti: contro la sua volontà.
E la realtà di oggi quanto entra in questi racconti? Sono estraniate da date ed eventi.
Ho scritto questi racconti nell’arco di 5 anni. Il primo, “La maledizione”, voleva essere un omaggio alla città di Aosta. L’ultimo è “L’ultima salita”. Io amo il noir e l’horror, anche se ci sono generi più contemporanei: “Sexting” e i racconti sull’anoressia. Io cerco di agganciarmi alle paure più ancestrali. Vorrei parlare di paura, scrivere un horror che fa paura adesso come l’avrebbe fatto cinquant’anni fa.
Anche le paure del contemporaneo?
Esatto, soprattutto la paura di non avere punti di riferimento: essere in balia, non essere sicuri. Quello che faccio è delineare la paura in una storia nella quale mancano punti di riferimento. Le paura ci sono sempre, con il benessere o con il non benessere. Paradossalmente, nel momento in cui c’è il benessere, come nel primo racconto, c’è questo maggior distacco, tra ricchezza e insicurezza generale di vita. Anche se stai bene, se hai fatto il massimo per garantirti una vita serena, succede qualcosa che ti fa smarrire.
È evidente anche una certa solitudine dei sentimenti e delle reazioni, delle decisioni prese in solitaria. In questo senso, il racconto più esplicativo è “Dopotutto”.
Volevo raccontare la storia di una donna che subisce uno shock biografico, cioè un evento, come un lutto, un fallimento, che crea una frattura, che distrugge, che devasta la vita della persona. Nel racconto ho scelto di parlare di una violenza sessuale. Ho cercato di informarmi il più possibile, su blog, su internet. La protagonista ha subìto questa grande tragedia nella sua vita, che ha segnato una specie di solco e lei cerca distrattamente per tutta la durata del racconto di dimenticare, di far finta che non sia esistito, finché non si rende conto che l’unica cosa da fare è accettare questa distruzione, questo cambiamento, e andare avanti: riconoscere quello che è successo ma … Dimenticare è impossibile… Però il cambiamento avviene in una condizione di solitudine estrema, o volontaria o involontaria.
Quando hai un problema sei veramente tu da solo a doverlo gestire.
Anche negli altri racconti le decisioni prese sono prese da sole. Anche quando uno si fa del male se lo fa da solo. Anche lei, in “Dopotutto”, dice che è colpa mia, si colpevolizza. È una condizione che attraversa un po’ tutti questi racconti, che sono tecnicamente e stilisticamente molto accelerati: spingono velocemente verso una fine inevitabile. Non è facile scrivere un racconto che ti tiene dalla partenza all’arrivo in sospeso. In “L’elfo fratello” va in scena la decostruzione dell’uomo; e alla fine rimane solo il meccanismo che fa andare avanti in maniera inerziale. Anche qui la solitudine c’è, perché non c’è nessuno che ti rallenta in questa corsa: si consuma tutto nello spazio ridotto. I racconti, in generale, non sono facili, da scrivere; nella tradizione italiana abbiamo pochi autori degni di questo nome…
Perché i racconti vengono valutati poco. Le stesse case editrici son le prime a non valorizzarli.
Il pubblico italiano è anche meno abituato di altri alla fruizione del racconto, ma in generale nel nostro paese manca proprio una tradizione del racconto. Il romanzo è più semplice perché ti permette di recuperare, in altre parti, eventuali cali di tensione narrativa. Il racconto, all’opposto, non dà possibilità di recuperare. I tuoi son racconti che narrativamente funzionano in maniera eccezionale. Interessantissimi, ancora, quelli sull’anoressia, già a cominciare dal titolo…
Ho scritto “Le bambole non mangiano” perché avevo una compagna di scuola che aveva una forma pura di anoressia; lei ha scritto un libro sulla malattia, io l’ho letto e secondo me non diceva le cose come andavano dette. Ho scritto un racconto perché è la mia dimensione. Mi sono iscritta su myspace, ho creato un profilo, ho dovuto mettere delle foto in cui ero molto magra perché altrimenti non ci sarebbe stato un contatto con nessuna, e ho cominciato a conoscere tante ragazze. Una aveva scritto sul suo profilo “Dolls don’t eat”: secondo me il titolo rendeva molto bene l’idea. Quest’idea di essere come bambole: non soffrire, non amare, non mettersi in gioco, non far nulla che potesse fare male; preservare la bambola e preservarti nell’anima. Alcune concetti trasformati in racconto le ho derivati dai colloqui avuti con le ragazze, alcune delle situazioni son prese proprio dalle loro vite. È la mia visione della malattia: la fiammella se non ce l’hai dentro nessuno può far niente. “Le bambole non mangiano” è, per altro, uno dei pochi miei racconti che finisce bene: nel senso che la protagonista arriva a capire di poter vivere, pur avendo questa forma di malattia sempre accanto.
Parliamo della ricerca che fai per scrivere…
Io faccio tantissima ricerca quando scrivo perché il mio insegnante di scrittura creativa, che è anche il mio editore, mi ha spiegato questa cosa: quando tu scrivi devi sapere quello di cui stai scrivendo. Per questo faccio tantissima ricerca ed è una parte molto interessante della scrittura. Per “L’ultima salita”, ad esempio, sono andato addirittura alla sede delle guide alpine per sapere come potrebbe essere un cadavere che cade giù da una montagna: la descrizione del cadavere me l’ha data una guida!
Gran parte della ricerca, a quanto ho capito, avviene tramite la dimensione del blog, che oramai fa parte del nostro mondo: è quasi una nuova forma di cultura, che non si fa più sulla carta…
Permette di venire a contatto anche con persone che hanno i tuoi interessi. È un modo più facile e naturale, anche per le possibilità di aprirsi, di confidare le cose.
Le ombre, invece? Qui, nei racconti, ce ne sono tante di ombre… Citi anche King; e Faletti, in apertura. L’ombra che cos’è?
Io sono speleologa; amo molto le ombre e il buio. Quando vado in grotta, ci sono momenti in cui cerco di restare da sola e spengo la luce: mi piace stare qualche minuto completamente al buio nella grotta e ascoltare i rumori. Sono molto più affascinata dal buio però, perché le ombre si muovono, sono più angoscianti.
Danno anche l’idea che qualche cosa ci sia, mentre il buio ti dà l’illusione che non ci sia nulla. Dall’ombra, io ti chiederei di Aosta. A me, trasferito da poco tempo, mi ha dato l’impressione di essere una città molto ombrosa, densa di ombre…
L’ombra ognuno ce l’ha dentro, e se ce l’ha dentro ce la può avere da ogni parte. Io amo molto Aosta e non posso dare ad Aosta la colpa delle ombre che ci sono. A livello architettonico Aosta è una città storica, fondata dai Romani, e prima ancora dai Salassi. Non ha ombre, Aosta; ha la storia. E la storia è fatta dalle persone. Se ci sono ombre nella città, non sono ombre della città ma delle persone che l’hanno abitata e vissuta.
Per questa presenza di antico e di nuovo, Aosta è una città composita: in una forma che neppure Roma è. Roma è molto più ariosa, ti dà la possibilità di scindere e capire quello che vedi. Aosta produce questo effetto molto compatto, quasi come se questi strati di storia si accavallassero, si sovrapponessero anche irregolarmente. Una città ribelle, a questo livello. Un po’ per la conformazione geografica, un po’ per il poco spazio dove costruire: Aosta ha un aspetto molto affascinante.
Aosta è particolare perché quello che più la caratterizza è il freddo. Non è una città comune, ma una città a misura d’uomo: ti dà delle possibilità, degli spazi da ritagliarti, che da altre parti non hai. Ma soprattutto devi combattere con il freddo. E il freddo, a differenza del caldo, non ti permette di lasciarti andare: il freddo devi combatterlo.
Anche è una città che stupisce: in pochi hanno percezione della ricchezza di Aosta. Ci sono dei resti archeologici che neanche a Roma ci sono più, come, ad esempio, il criptoportico. È una città anche molto nascosta, costruita sotto tutto quello che è cresciuto sopra: un aspetto che io avvicino alle ombre, come qualcosa che si cela.
Nei miei racconti le ombre sono sempre nell’interiorità dei personaggi, mentre invece l’ambiente è sempre abbastanza accogliente.
Nel racconto “La chiromante”, invece, ci sarebbe da chiederti se credi nel destino o nel caso…
Io non credo nel destino, nelle streghe, nei fantasmi, non credo nella vita dopo la morte e scrivo di queste cose proprio perché, non credendoci, posso usare uno sguardo di fantasia. Credo nella scienza. Credo nella casualità. Non mi piacciono i racconti con troppe coincidenze, perché nel racconto le situazioni devono avere una loro logicità. Nei racconti, le situazioni sono normali ma prendono delle pieghe interessanti, purché coerenti: è questo quello che cerco con la mia scrittura.
 ROMA – “Innovative Children’s Books“, questa è la scritta che compare sul sito della casa editrice Sassi Junior. Ed effettivamente questi libri per ragazzi sono innovativi nei materiali, nelle forme e nelle tematiche. Realizzati con inchiostri ecologici e oltre il 9o% di materiali riciclati, i volumi Sassi Junior parlano ai bambini (fin dai primi mesi di vita) e ai ragazzi di ecologia, riciclo e vita naturale. Allora, per scoprire come nascono questi libri dal cuore verde e come si sviluppa il progetto editoriale, abbiamo intervistato l’editore, Luca Sassi.
ROMA – “Innovative Children’s Books“, questa è la scritta che compare sul sito della casa editrice Sassi Junior. Ed effettivamente questi libri per ragazzi sono innovativi nei materiali, nelle forme e nelle tematiche. Realizzati con inchiostri ecologici e oltre il 9o% di materiali riciclati, i volumi Sassi Junior parlano ai bambini (fin dai primi mesi di vita) e ai ragazzi di ecologia, riciclo e vita naturale. Allora, per scoprire come nascono questi libri dal cuore verde e come si sviluppa il progetto editoriale, abbiamo intervistato l’editore, Luca Sassi.





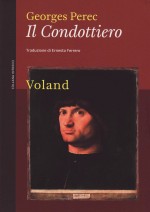







 Marianna Abbate
Marianna Abbate



