 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
ROMA – L’Africa. Ogni aggettivo, al cospetto di codesto nome, è superfluo, gravoso, impacciante. “Mama Africa” (come canta Chico Cesar) è la terra dell’origine, del primigenio, della lenta separazione dell’homo dagli ominidi. Ed è, oggi, anche la terra più in fermento, più vivace, più contraddittoria ma più potenzialmente sorprendente. ChronicaLibri ha intervistato Leo Finzi, l’autore del romanzo “L’Alhaji” (Gaffi editore): lui l’Africa la conosce bene, conosce soprattutto la Nigeria, una delle nazioni che si esagerano come dominanti e guide della riscossa africana. La conversazione che ne è venuta fuori pone degli accenti interessanti sia sul romanzo che sulla situazione geo-politica, accendendo in noi stimolanti curiosità per comprendere questo nostro mondo che dovrà assumersi la responsabilità di scelte importanti.
Devo subito confidare una mia simile passione per l’Africa: io son stato in Kenya, nella baraccopoli di Huruma, per una manciata di settimane, ma nonostante la breve permanenza ho sviluppato fin da subito quello che, poeticamente, gli antichi battezzarono il “mal d’Africa”. Io so cos’è, me lo sento sottopelle un po’ tutti i giorni della mia quotidianità: vorrei però che lei lo spiegasse, considerando che, in Africa, ha trascorso molto più tempo di me.
Dunque, il “mal d’Africa”. Credo vi siano diverse componenti che si fondono a comporre questo sentimento di attrazione, fascinazione vagamente malinconica e quasi nostalgica che gli europei hanno chiamato “mal d’Africa”. L’aspetto più interessante e anche più profondo di questo stato d’animo è secondo me quel particolare senso di straniamento che produce in un europeo l’immergersi in un ambiente naturale e umano percepito, a torto o a ragione, come “primitivo” (dando a questa parola una connotazione tutt’altro che negativa). L’Africa, sia nella natura che negli uomini, rappresenta per un europeo uno stato più basilare, meno assoggettato alle regole della civiltà e quindi meno convenzionale, più misterioso e imprevedibile, meno utilitario, più terribile per certi aspetti, ma anche più innocente, meno spiegato e al tempo stesso più vero. L’Africa rappresenta quasi uno stato anteriore e una componente del “mal d’Africa” è una sorta di nostalgia del caos che precede l’ordine umano, e pare più vicino alla verità. Situazioni diversissime contribuiscono a creare questa percezione: dal contatto quotidiano, crudo e quasi brutale, coi problemi basilari, di sopravvivenza umana, in cui ci s’imbatte di continuo, tanto nei minuscoli villaggetti sperduti nel bush quanto nelle terribili bidonville delle metropoli africane; alla natura così poco umanizzata e tanto più presente; alle forme di cultura; al rapporto con il tempo: sa che la maggior parte delle lingue africane non ha il modo condizionale né il periodo ipotetico? Ovvero non ha le forme grammaticale e sintattica attraverso le quali un europeo, tramite il linguaggio, cerca d’introdurre una logica e un ordine nel tempo a venire.
Oltre alla cultura, alla storia, a forse, come ha osservato anche lei, un senso di ritorno alla primigenia culla evolutiva che l’uomo sente per le terre dell’“Africa nera”, i tempi si evolvono e anche l’Africa sta evolvendo. La Nigeria è, come ho scritto anche nella mia recensione, una terra dalle potenzialità impressionanti; ma dalla profonda confusione politica e dall’ancora più irrisolvibile intolleranza sociale e religiosa. Lei che la conosce così bene potrebbe magari illustrarci un po’ più chiaramente la situazione di questo stato che potrebbe, realmente, candidarsi a diventare una potenza assoluta?
È vero che l’Africa sta evolvendo. E la Nigeria è, anche in questo – cioè nel contrasto tra i retaggi della civiltà tribale, l’identità culturale originaria africana, la sua “primitività” e, d’altra parte, la giusta aspirazione allo sviluppo economico e sociale, attraverso l’inevitabile e talora traumatico assorbimento di una cultura che non ha prodotto – un paese emblematico dell’Africa post-coloniale. Con i suoi 160 milioni di abitanti, la Nigeria è il paese più popoloso del continente. Una nazione potenzialmente ricca e forte, perché ha il petrolio, e lo sfrutta da molti anni. Non è, quindi, l’Africa povera. È un paese a sua volta pieno di contraddizioni, la cui popolazione è l’amalgama di molte etnie diverse; un paese diviso letteralmente in due tra un nord radicalmente musulmano e un sud fortemente cristiano, periodicamente insanguinato da scontri etnici e religiosi. È uno dei pochi paesi africani ormai dotato di un embrione di economia “moderna” sviluppata, interamente amministrata da neri e che cerca anche di acquisire un ruolo sul piano internazionale, ma dove persistono, al tempo stesso, una fortemente radicata cultura tribale e vastissime aree di povertà e di arretratezza, di economia primitiva. Anche per questi forti contrasti, credo che la Nigeria possa essere considerata un po’ un laboratorio dello sviluppo dell’Africa post-coloniale. Un Paese che da un lato ha già raggiunto un fortissimo grado di urbanizzazione; un Paese in cui, d’altra parte, accanto alla gente povera delle città – le plebi urbane che si ammassano nelle sterminate e atroci bidonville dove si vive senza servizi igienici, ma magari sui tetti in lamiera delle baracche spuntano le parabole satellitari e tutti usano il telefonino – a distanza di pochi chilometri vi sono villaggetti di capanne di paglia e fango che campano d’allevamento brado e di piccola agricoltura, legati a un’economia tribale di sopravvivenza, dove vive ancora buona parte della popolazione. Però, tra queste due fasce ancora largamente maggioritarie della popolazione, si va inserendo il cuneo spingente di una sorta di classe media ormai abbastanza solida, sicuramente la più numerosa e diffusa dell’Africa; la classe di quelli che forse ormai ce l’hanno fatta a uscire dalla povertà, hanno un impiego in qualche banca o ministero o impresa, vivono in una casa decente, posseggono una macchina e magari risparmiano per comperarsene una migliore, o per mandare almeno uno dei figli all’università, magari all’estero.
L’ho paragonata a Conrad. E ho accostato il suo “L’Alhaji” a “Cuore di tenebra”. Ovviamente, andrebbero fatte tutte le distinzioni del caso, ma credo che le funzioni dei due libri siano più o meno similari. Ho scritto nella mia recensione che, così come Conrad “denunciò il feroce colonialismo ottocentesco, scarsamente documentabile e, per questo, difficilmente rimproverabile dai suoi contemporanei, ‘L’Alhaji’ illustra, con un piglio giornalistico ma con un’architettura raffinatamente narrativa, il colonialismo dell’oggi, del presente, dei nostri anni Zero”. Mi pare superfluo chiedere se ha letto Conrad, ma più interessante sarebbe sapere se le garba e se, in qualche maniera, la lettura dello scrittore polacco abbia effettivamente influito sulla sua scrittura.
Conrad è uno dei miei autori preferiti e “Cuore di tenebra” uno dei suoi libri che più ho amato. Il solo fatto che lei li menzioni con riferimento a “L’Alhaji” mi fa naturalmente un enorme piacere. Conrad è uno dei grandi scrittori che rileggo di frequente e che più hanno contribuito alla mia formazione letteraria. Se poi devo provare a individuare in cosa, nello specifico, Conrad abbia influito su “L’Alhaji” o più in generale sulla mia scrittura, sarei portato a indicare almeno due aspetti. Il primo è la forma dei conflitti morali e dei contrasti interiori che caratterizzano i grandi personaggi di Conrad, il modo ellittico e mai chiaramente risolto in cui Conrad stesso li descrive, come girandovi ripetutamente intorno, tenendosi a rispettosa e prudente distanza, come un marinaio che circumnavighi coste frastagliate e pericolose, delineando senza pretendere di penetrarlo il nocciolo irrazionale che quei conflitti contengono e che di fatto determina l’azione del racconto e il destino dei personaggi. Il secondo è la corrispondenza intermittente – ora ossessiva, ora catartica e liberatoria – tra la descrizione di quei conflitti e la descrizione della natura (nel caso di Conrad la grande Natura del mare, con le sue forze immense, le sue imperscrutabili tempeste e bonacce). La natura è una componente attiva e determinante nella scrittura di Conrad e fa metaforicamente da specchio, narrativamente da teatro e compositivamente da contrappunto ai conflitti umani raccontati nei suoi libri. Basterebbe, per fare un esempio, la meravigliosa citazione da Baudelaire che Conrad premette alla sua più bella storia di bonaccia, “La linea d’ombra”: “… D’autres fois, calme plat, grand miroir. De mon désespoir”. E visto che siamo in tema, mi permetto un’altra citazione da Conrad, sempre a proposito d’inspiegati conflitti morali; è la conclusione del capitano Giles, ancora dalla “Linea d’ombra”: “…. un uomo proprio deve affrontare la sua cattiva sorte, i suoi errori, la sua coscienza. Perbacco, contro che cosa vorreste lottare altrimenti?”
Non ci son soltanto la Nigeria e l’economia, nel suo romanzo. Ci sono anche dei rapporti umani, dei legami tra uomini e donne, tra uomini e uomini, tra donne e donne. C’è, insomma, una fitta e densa umanità che si caratterizza per i rapporti burrascosi e per i legami un po’ fragili e un po’ ricattanti, sempre al limite della sopportazione e del collasso. Ha inteso presentare questi personaggi come pura fiction, da collocare nel setting dell’Africa, oppure tali rapporti sono, per così dire, un correlativo oggettivo della difficile situazione della Nigeria stessa?
Il personaggio dell’Alhaji racchiude certamente in sé quel conflitto tra primitività e modernità, tra l’originaria cultura tribale e l’ancestrale comunione con la natura da un lato, e l’aspirazione allo sviluppo e il conseguente assorbimento di una cultura estranea, nonché il rapporto utilitario con l’ambiente dall’altro, di cui si parlava poc’anzi e che sono alla radice delle contraddizioni non solo della Nigeria, ma direi di tutta l’Africa post-coloniale. “Alhaji” è il titolo che in Nigeria prendono i musulmani che si sono recati in pellegrinaggio alla Mecca. Ha finito col diventare una sorta di titolo onorifico di cui si fregiano alcuni esponenti di ricche e potenti famiglie musulmane. L’Alhaji – capo della sua comunità, leader politico legato alle tradizioni della sua terra e della sua gente e, al tempo stesso, moderno business man che ha studiato in Inghilterra e fa affari in giro per il mondo – incarna questi contrasti, questo coacervo di contraddizioni, e mette in mostra le lacerazioni profonde che le due istanze contrapposte di cui parlavamo aprono nell’identità degli africani. Ma vi sono anche altri contrasti forti che caratterizzano i rapporti umani descritti nel libro. Attorno all’Alhaji si svolgono vicende perlopiù interpretate da bianchi, ed è giocoforza dal punto di vista di un bianco che tali vicende vengono narrate. Però i bianchi dell’Alhaji, a cominciare da Nevio, sono tutti dei transfughi, appartengono a una di quelle enclavi straniere che s’impiantano, per breve o lungo tempo, in Africa. È un mondo di frontiera, in cui il tema razziale, il rapporto tra bianchi e neri, fa da sfondo a ogni cosa e l’incontro ravvicinato, spesso abrasivo, tra civiltà e culture molto lontane tra loro, scuote i fondamenti morali dell’una e dell’altra e genera un’atmosfera di valori rarefatti, come una sorta di terra franca in cui è facile perdersi.
Proprio sull’Alhaji volevo rivolgerle l’ultima domanda. In parte ha già risposto, ma vorrei un po’ approfondire questa figura, per noi, remota anche nella definizione. L’Alhaji: la figura emblematica del potere, di chi e di come lo detiene. Una figura che imbarazza ma che esiste; e se esiste è per gran parte colpa della società occidentale, quella che, fino a poche settimane fa, pareva invincibile e insostituibile. Il crollo, nemmeno troppo lento e oramai inevitabile dell’anziana Europa e del vecchio modello capitalistico che conseguenze avrà, secondo lei, sul fragile equilibrio dell’Africa e, in particolar modo, dei paesi che, più di altri, avrebbero le risorse per esagerarsi potenze d’un futuro non molto lontano?
Quando ho cominciato a scrivere l’Alhaji, il punto di partenza è stato molto semplice. Noi europei abbiamo una visione pregiudiziale dell’Africa: è il continente che conosciamo meno e ce lo raffiguriamo come una terra di povertà, bisognosa di aiuto, di assistenza sanitaria e alimentare, di guida allo sviluppo, di programmi di aiuti; una terra di popolazioni in fuga, di emigranti e rifugiati che malvolentieri accogliamo in casa nostra, di bambini da adottare a distanza, di popoli affamati cui fare la carità, che hanno bisogno del nostro sostegno perché ancora incapaci di camminare con le proprie gambe. Bene, mi sono detto, proviamo a scrivere la storia di un africano ricco; di un africano potente, autonomo e forte e proviamo a descrivere i meccanismi del potere in Africa, che forse gli europei si illudono ancora di controllare, mentre io credo che ormai da decenni – per fortuna degli africani – non sia più così. E così è nato l’Alhaji. Non ho dovuto inventare molto, perché avevo sotto gli occhi situazioni non troppo diverse da quelle che ho raccontato. È venuto addirittura fuori (ma le assicuro, non per scelta ideologica bensì per rappresentazione realistica ed economia narrativa) un rapporto servo-padrone rovesciato, in cui Nevio (bianco) è assoggettato all’Alhaji (nero). Voglio anche aggiungere che, sotto questo aspetto, mi ha fatto molto piacere scrivere una storia di orgoglio africano. L’Africa ha sempre avuto una sua cultura e una sua organizzazione sociale, e quindi anche una sua propria struttura del potere. È forse una novità per noi europei (ma non credo che lo sia per gli africani) scoprire che da anni ormai, e sempre più, si vanno affrancando dalla tutela bianca. Il fatto che questo vada di pari passo col declino dell’Europa e forse con l’ascesa dell’influenza di altre potenze in Africa (in particolare la Cina, che da tempo penetra sempre più a fondo nel continente africano e ha un gran bisogno delle sue materie prime) secondo me è solo marginale: l’Africa oggi è cambiata, è autonoma; indipendentemente da quello che gli altri (europei, cinesi o americani) fanno attorno a lei, ha ormai una sua economia, che tutti gli indicatori danno in espansione (anche più rapida delle economie asiatiche); inoltre ha una popolazione giovane, che cresce a un tasso che oggi non ha riscontro in nessun’altra area del pianeta. Certo, i paesi africani sono ancora pieni di contraddizioni, di enormi difficoltà, di contrasti violenti; ma le difficoltà sono anche opportunità e c’è effervescenza in numerose nazioni dell’Africa, assai più di quanta ve ne sia mai stata prima. Tornando al libro e alla prima parte della sua domanda, attraverso l’Alhaji ho cercato di dare una rappresentazione del potere in un paese-guida dell’Africa, la Nigeria. Ho tentato di illustrare i suoi meccanismi, con un taglio realistico-oggettivo, provando ad astenermi da qualunque giudizio morale. Credo che il risultato sia stato narrativamente ambiguo: l’Alhaji, pur dando il titolo al libro e pur avendo molte pagine a lui dedicate, come personaggio è forse il meno definito del romanzo (credo che diversi altri personaggi, magari descritti in poche pagine, siano più intensi). D’altra parte, l’Alhaji fa come da veicolo per illustrare alcuni aspetti della società nigeriana e per investigare la forma che prende il potere in un contesto come quello nigeriano, dove i retaggi di una cultura arcaica e tribale (di cui il popolo, e quindi anche necessariamente chi, come l’Alhaji, aspira a guidarlo, è portatore) si mescolano o si scontrano con le esigenze dell’economia di un moderno paese petrolifero e anche con le genuine aspirazioni di quello stesso popolo allo sviluppo, all’uscita dalla povertà, al benessere. I contrasti e le contraddizioni interiori dell’Alhaji sono i contrasti e le contraddizioni del suo popolo e sono un dato storico oggettivo che l’Africa non può evitare di affrontare.
 Marianna Abbate
Marianna Abbate












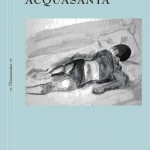



 Marianna Abbate
Marianna Abbate