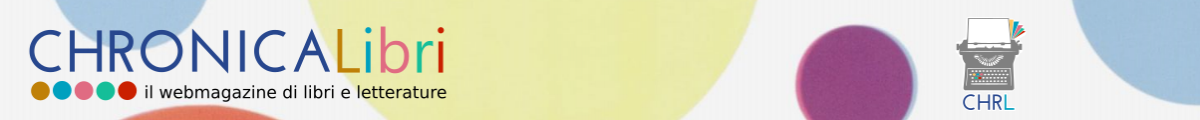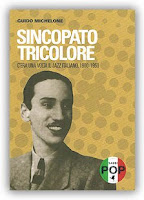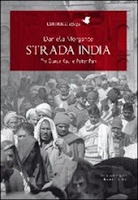Agnese Cerroni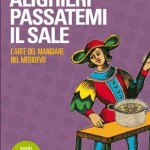
ROMA – Cosa si mangiava nel Medioevo? E perché? Cosa è rimasto di tutto ciò nell’alimentazione di oggi? La storia del cibo raccontata da Anna Pischedda in “Alighieri passatemi il sale. L’arte di mangiare nel Medioevo” Edizioni Effequ, è una storia affascinante perché, come quella del pensiero, ricca di scoperte e di imprese anonime, ma non per questo meno importanti e meno appassionanti: nell’alimentazione l’atto più fisiologico e materiale diventa anche momento rivelatore di cultura e simbolismo. D
Categoria: effequ
"Shakerato non mescolato". Il cocktail che vuoi, come e perché lo vuoi
Giulia Siena
ROMA – “Far bere e bere si assomigliano: ci vuole passione per entrambe le cose. Una passione costante, giornaliera, e non occasionale. Non si dovrebbe mai bere una sola sera o un solo giorno a settimana, e bisognerebbe sempre bere la quantità di alcol che si è in grado di reggere. Fine delle avvertenze.” Tali sono le avvertenze che Enrico Piscitelli specifica nel suo “Shakerato non mescolato. Guida al mondo dei cocktail e dei bar”, il libro pubblicato nella collana Saggi Pop dell’Editrice Effequ. Aneddoti, cinema e ricette si “shakerano” amabilmente con lo stile un po’ bohémien dell’autore pugliese.
Piscitelli ci consiglia di consumare il Negroni – cocktail che prende il nome dal celebre conte fiorentino che lo ha inventato – appena prima di cena, con qualcosa da stuzzicare. Poi ci illustra la semplicità e la tradizione del Garibaldi – drink bevuto anche da Richard Burton e Chuck Norris – fatto solamente con bitter rosso e succo d’arancia, servito in un highball glass. E come dimenticare il White Russian, “diventato un cult drink a cavallo dell’anno Duemila, grazie a un film di Joel ed Ethan Coen: Il grande Lebowski”, perfetto after dinner da consumare solo se fatto con ottime materie prime. Tante storie di alcolici famosi e non, correlati da ricette, curiosità e quattro chiacchiere con chi i cocktail li crea: i barman.
"Garibaldi fu sfruttato": dove sta il vero personaggio?
L’agevole “saggio pop” pubblicato dalle effequ, “Garibaldi fu sfruttato” è un interessante chiave – direi propedeutica – per avvicinarsi a capire chi fu, veramente, l’eroe-dei-due-mondi, nato in una terra che da italiana diventò francese (e da qui, si narra, la sua avversione per Cavour).
 , dottore di ricerca in Pensiero politico e comunicazione nella storia, già autrice di interessanti saggi, ha schematizzato, in chiave appunto “pop”, non tanto la figura del condottiero stesso, presentandocelo (grazie anche a un attento e puntale apparato di note) attraverso la sua vita e le sue imprese leggendarie, ma calibrandolo nelle vari riletture (e nell’abuso) che della sua figura furono fornite da qualsiasi partito o corrente politica, da qualsiasi teorico o politico della storia dell’Italia contemporanea. Garibaldi fu il condottiero amante della guerra che si cercò di presentare per giustificare la politica d’inverventismo nel 1914 o fu il Garibaldi delle Brigate che parteciparono alla Guerra di Spagna contro Franco e gli eserciti fascisti? Fu il Garibaldi amante della terra che, con le proprie mani, fece dar frutto alla pietraia solitaria di Caprera o fu il Garibaldi latin lover, anzitempo vitellone, che faceva cadere ai suoi piedi, come pere cotte, tutte le donne che incontrava (qualcuna finanche spingendola ad abbracciare la sua causa guerriera e a partecipare attivamente alle sue azioni)? L’argomento è stato sviscerato in pagine e pagine rilegate e pressate, in fiumi d’inchiostro e di ipotesi, in stravaganze di teorie.
, dottore di ricerca in Pensiero politico e comunicazione nella storia, già autrice di interessanti saggi, ha schematizzato, in chiave appunto “pop”, non tanto la figura del condottiero stesso, presentandocelo (grazie anche a un attento e puntale apparato di note) attraverso la sua vita e le sue imprese leggendarie, ma calibrandolo nelle vari riletture (e nell’abuso) che della sua figura furono fornite da qualsiasi partito o corrente politica, da qualsiasi teorico o politico della storia dell’Italia contemporanea. Garibaldi fu il condottiero amante della guerra che si cercò di presentare per giustificare la politica d’inverventismo nel 1914 o fu il Garibaldi delle Brigate che parteciparono alla Guerra di Spagna contro Franco e gli eserciti fascisti? Fu il Garibaldi amante della terra che, con le proprie mani, fece dar frutto alla pietraia solitaria di Caprera o fu il Garibaldi latin lover, anzitempo vitellone, che faceva cadere ai suoi piedi, come pere cotte, tutte le donne che incontrava (qualcuna finanche spingendola ad abbracciare la sua causa guerriera e a partecipare attivamente alle sue azioni)? L’argomento è stato sviscerato in pagine e pagine rilegate e pressate, in fiumi d’inchiostro e di ipotesi, in stravaganze di teorie.Ma un dubbio permane, al di là di tutto. Ovvero che Garibaldi fosse, in definitiva, soltanto un uomo; un uomo con le sue idee (travisate) e coi suoi caratteri (ignorati). Un uomo che, con assoluta certezza, credé in qualcosa: e par essere questo un sufficiente merito.
Patrizia Laurano
"Sincopato tricolore": come i ritmi afroamericani riuscirono a conquistare il paese del melodramma.
Alessia Sità
"Strada India", un viaggio alla ricera di sé
ROMA – “Strada India” di Daniela Morgante, Editrice effequ, è il racconto di un viaggio compiuto a metà degli anni Settanta dall’autrice, allora studentessa universitaria.
Il viaggio rappresentava una strada per la ricerca di sé e di nuove mete per costruire una società migliore.
Nel presentare questa personale, significativa esperienza, la scrittrice oltre a rendere il lettore partecipe delle emozioni e delle sensazioni scaturite dall’incontro con una realtà e con un mondo così diversi dalla sua Maremma, vuole anche coinvolgerlo nell’atmosfera di quegli anni, offrendogli una chiave per comprendere il contesto in cui maturarono i sogni, le idee dei ragazzi di allora.
I luoghi, le persone incontrate, i profumi, i colori dell’India sono rievocati con uno sguardo intriso di affettuosa nostalgia, ma nello stesso tempo ormai distaccato per la lontananza che pone il tempo trascorso.
Con uno stile essenziale, ma di grande efficacia narrativa, Daniela Morgante conduce il lettore nell’itinerario di viaggio da lei condiviso con tre amici, vissuto con giovanile allegria e con una certa ironia tutta toscana, capace di sdrammatizzare le situazioni più spiacevoli.
"All’ombra di Caravaggio", un’ipotesi non fa la storia. Ma la umanizza.
“All’ombra di Caravaggio”