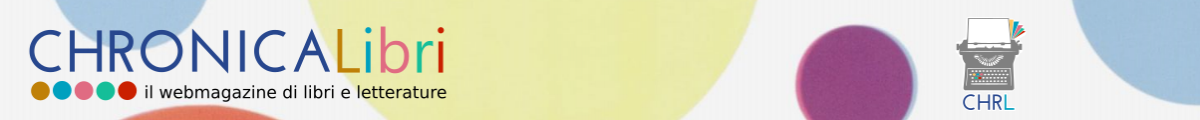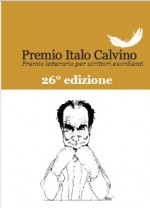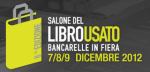Veruska Armonioso
Veruska Armonioso
ROMA – Venerdì a pranzo ero con un’amica d’infanzia, una di quelle che conoscono tutto il necessario di te: come sei venuta al mondo, da dove vieni, chi volevi essere da grande; una di quelle persone che possiedono le tue origini. Insomma, siamo andate a pranzo insieme dopo un po’ che non ci vedevamo e, come al solito, è bastato poco per riprenderci. Qualche nome per posizionare il treno sulle rotaie giuste e poi via, a parlare. Lei, mamma di due bambine, dalla morte del padre è stretta nella morsa infernale del passaggio di testimone: l’acquisizione in eredità paterna del ruolo di capofamiglia e la restituzione alla madre (rimasta, senza suo marito accanto, senza strumenti e incoraggiamento per essere genitrice) di quello di figlia. Uno scambio ambiguo e controverso che mi ha fatto subito venire alla mente Anne Ancelin Schützenberger e il suo libro “La sindrome degli antenati”.
Avevo letto questo libro dopo qualche mese dalla morte di mia madre. In quel periodo mi sentivo come dispersa nel mezzo dell’oceano, senza futuro e senza passato; ero fermamente convinta di aver perso bussola e i riferimenti necessari per andare avanti e che, quindi, non avrei toccato terra mai più: destinata alle sabbie mobili senza affondare mai del tutto. Poi, aprii la prima pagina di questo libro e iniziò la mia catarsi:
“La vita di ciascuno di noi è un romanzo. Voi, me, noi tutti viviamo prigionieri di un’invisibile ragnatela di cui siamo anche uno degli artefici. Se imparassimo dal nostro terzo orecchio e del nostro terzo occhio ad afferrare, a comprendere meglio, ad ascoltare e a vedere queste ripetizioni e coincidenze, l’esistenza di ciascuno di noi diventerebbe più chiara, più sensibile a ciò che siamo e a ciò che dovremmo essere.”
Le ripetizioni a cui si riferiva erano ripetizioni famigliari, lacci tra noi e quello che c’è stato prima, che spesso ignoriamo a livello conscio e che, invece, creano dal profondo le fondamenta della nostra esistenza. Quante volte ci hanno detto che il modo di amare di una madre ha decretato quello di amare di un figlio? E ancora più scientificamente: quanti di voi hanno preso il colore dei capelli dal bisnonno?
Filosofeggiando e poetizzando sui principi di genetica di Mendel, possiamo facilmente pensare che, se una bisnonna può trasmetterci il gene dei capelli rossi, può altresì trasmetterci quello della docilità. E’ lì, proprio in quella fessura, che accade la ripetizione famigliare, il reiterarsi, cioè, non solo di modelli comportamentali tra una generazione e l’altra, ma addirittura di accadimenti, anniversari, incidenti, sorprendentemente sinistri, come nel caso di una donna che si ammala di cancro esattamente alla stessa età in cui si è ammalata sua madre, oppure di un uomo che ha un incidente automobilistico il giorno di Natale, esattamente come successe a suo nonno, che non conobbe mai e che perse in quell’occasione la vita.
“Siamo, in un certo senso, meno liberi di quanto crediamo”, ostaggi di legami con i nostri antenati che si possono “vedere, sentire o intuire, almeno in parte, ma di cui, generalmente, non si parla: vengono vissuti nell’indicibile, nell’impensabile, nel non – detto o in segreto”.
Esiste una letteratura di casi studiati vastissima, ma ciò che più mi interessava trasferire alla mia amica era legato allo scambio malato dei ruoli tra genitore e figlio, la genitorializzazione, che accade, quasi sempre, quando c’è un caso di debito di lealtà invisibile.
La famiglia, in quanto unità sociale, si fonda sulla lealtà dei membri che la compongono. “Da qui il concetto di giustizia e di giustizia famigliare. Quando non viene fatta giustizia, la situazione si traduce in ingiustizia, in malafede, nello sfruttamento dei membri della famiglia gli uni nei confronti degli altri, talvolta attraverso la fuga, la rivalsa o la vendetta, altre volte attraverso la malattia o l’incidente ripetitivo.” Diversamente accade quando c’è l’affetto, la considerazione reciproca e i conti famigliari vengono aggiornati. Si può parlare di un bilancio dei conti famigliari e del grande libro dei conti famiglia, dove si vede se si è debitori o creditori, se di hanno debiti, impegni o meriti. “In mancanza di questo bilancio, di generazione in generazione, ci possono essere una serie di problemi”.
Anne Ancelin Schützenberger ci dice che il più grande debito della lealtà famigliare è quello che ogni bambino contrae nei confronti dei genitore, per amore, affetto, cure, fatica e attenzioni che riceve dalla nascita, fin quando non diventa adulto.
Per virtù o causa di questo ‘debito’, a un certo punto della vita del figlio avviene il rovesciamento dei valori, ossia della situazione in cui i figli diventano i genitori dei propri genitori; questo può accadere indipendentemente dall’età del figlio: “vi è un certo numero di famiglie, soprattutto quelle modeste o rurali, dove la figlia maggiore ricopre il ruolo di madre e dove la madre, stremata dalla fatica per i parti troppo numerosi, realmente malata o ritenendosi malata, si fa sorreggere, aiutare e sostenere da sua figlia, la quale non si sposerà mai.”
E così, una figlia che a vent’anni, dopo la morte del padre, si ritrova a fronteggiare il peso emotivo di una famiglia sostituendosi alla madre, diventerà madre della sua stessa genitrice fino alla fine dei suoi giorni, a meno ché non decida di interrompere questa distorsione malsana delle relazioni, imparando a conoscere il proprio ‘libro dei meriti e dei debiti’, “…attraverso un’analisi dell’informazione retrospettiva, vale a dire della memoria dei vivi sui morti: ciò che le persone viventi sanno delle loro famiglie e ciò che le agisce, anche se esse non sanno coscientemente ciò che sanno, tra il detto e il non detto, tra il conscio e l’inconscio – ciò che è stato trasmesso dal punto di vista della famiglia.”
Sarà a quel punto che si salderà davvero il proprio debito, ossia attraverso il passaggio transgenerazionale, rendendo quel che abbiamo ricevuto dai nostri genitori ai nostri figli.
“Questo non ci impedirà, quando i nostri genitori saranno vecchi, di avere nei loro confronti delle attenzioni e dei debiti, tra cui quello di aiutarli a vivere i loro ultimi anni e di accompagnarli nel passaggio dalla vita alla morte”, ma ci permetterà di mantenere il possesso della nostra identità e della possibilità di scegliere per noi stessi, senza subire sensi di colpa o frustrazioni da negazione dell’io ed essere pilotati dei bisogni e dalle esistenze dei nostri antenati.
Un punto di partenza, senza dubbio, questo libro, ecco cosa è stato per me. Non una cura, non una soluzione, ma uno spostamento. In me ha spostato una convinzione, quella che non sarebbe cambiato niente, che “tanto le cose stanno così, è il mio destino, e non c’è niente che si possa fare”. E invece no. Si rompono le catene, senza rinnegare, senza rifiutare, senza ignorare, semplicemente lavorando sulle altre possibilità che non vediamo ma di cui possiamo disporre. Alcuni strumenti ci vengono dati in dotazione dalla natura o da Dio, per chi è credente. Altri dobbiamo andarli a cercare. E’ quella la difficoltà, andare a cercare qualcosa che non sai ti possa servire; quindi scoprire che ti serve quello strumento diventa fondamentale. Ecco perché questo articolo. Perché, magari, anche voi siete come me e la mia amica, ancorati saldamente a un blocchetto di cemento a presa rapida, pensando che non ci sia uscita e che la vita sia segnata dal subire quel destino.
E invece no, non è così che stanno le cose. E non dico che oggi sono dove sono grazie a “La sindrome degli antenati”, ma che leggerlo mi ha aiutata a capire che mi servivano quegli strumenti, che io, cresciuta con un senso del dovere schiacciante, nel costante bilanciamento tra la ricerca della perfezione e la delusione delle aspettative altrui, io e solo io dovevo intervenire, subito. Che non mi potevo sostituire a nessuno, che la mia identità doveva essere inviolabile, che ero venuta al mondo per essere libera e che avrei dovuto scegliere da me il mio destino. Intervenendo, subito, su di esso.
Che il nostro albero genealogico racconti le nostre origini; che noi raccontiamo il nostro futuro.
 ROMA – Quarta edizione per il Festival della Narrativa Francese in programma in 15 città Italiane fino a sabato 9 marzo. Dopo il successo del 2012, l’FFF torna nella Capitale con un ricco calendario di eventi per presentare “dal vivo” la letteratura francese più contemporanea. 16 autori di libri in lingua francese recentemente pubblicati in Italia si avvicendano sui palchi di Italia per confrontarsi e presentarsi.
ROMA – Quarta edizione per il Festival della Narrativa Francese in programma in 15 città Italiane fino a sabato 9 marzo. Dopo il successo del 2012, l’FFF torna nella Capitale con un ricco calendario di eventi per presentare “dal vivo” la letteratura francese più contemporanea. 16 autori di libri in lingua francese recentemente pubblicati in Italia si avvicendano sui palchi di Italia per confrontarsi e presentarsi.