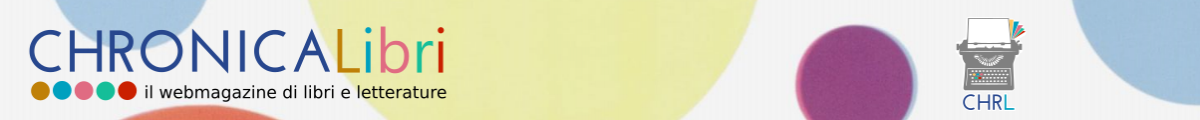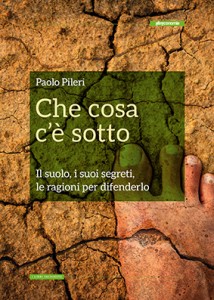 MILANO – Sabato 5 dicembre sarà la Giornata mondiale del suolo ed è forse la data giusta per scoprirsi “partigiani del suolo”. Non solo perché – come ripete spesso Paolo Pileri, autore del libro Che cosa c’è sotto. Il suolo, i suoi segreti, le ragioni per difenderlo (edito da Altraeconomia) – “il suolo è bello”, ma perché è proprio il suolo che ci sostiene, ci nutre, ci fa respirare.
MILANO – Sabato 5 dicembre sarà la Giornata mondiale del suolo ed è forse la data giusta per scoprirsi “partigiani del suolo”. Non solo perché – come ripete spesso Paolo Pileri, autore del libro Che cosa c’è sotto. Il suolo, i suoi segreti, le ragioni per difenderlo (edito da Altraeconomia) – “il suolo è bello”, ma perché è proprio il suolo che ci sostiene, ci nutre, ci fa respirare.
Questo testo spiega infatti in modo chiaro che la risorsa più preziosa è proprio sotto i nostri piedi: un piccolo strato che è in grado di trasformare la morte in vita, e di renderci servizi inestimabili, come il ciclo del cibo, la conservazione della biodiversità, la regolazione climatica e la captazione delle acque.
Lo spiega anche la Commissione Europea, che definisce suolo “lo strato superiore della crosta terrestre costituito da componenti minerali, sostanze organiche, acqua, aria e organismi viventi”, e lo identifica come “l’interfaccia tra terra, aria e acqua”.
Per questo – sostiene Pileri, professore di Pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano – il suolo è un vero e proprio “bene comune” e una risorsa non rinnovabile – per generare 2,5 centimetri di suolo “vivo” ci vogliono 500 anni – che però oggi è sottoposta a numerose minacce: ancora nel 2015, proclamato dalle Nazioni Unite “Anno internazionale dei suoli”, il suolo viene vilipeso, calpestato e distrutto. La minaccia più grave e immediata è il consumo di suolo: solo in Italia, a causa di interessi rapaci e di piani urbanistici dissennati e frammentati tra migliaia di Comuni, si consumano infatti 8 metri quadrati di suolo fertile al secondo, e la superficie antropizzata ha ormai superato i 22mila chilometri quadrati.
Che cosa c’è sotto racconta il suolo in modo divulgativo, perché è solo attraverso una conoscenza accurata di questa risorsa che sarà possibile invertire la rotta: l’ISPRA certifica che ogni anno in Italia si perdono 70 ettari si suolo. Ogni giorno a causa delle “conseguenze del cemento” il nostro Paese perde una superficie in grado di produrre cibo per 420 persone, mentre aumenta di 259 milioni di litri il volume potenziale delle acque da gestire.
Le minacce al suolo – come dimostra il caso lombardo – sono rappresentate dall’edilizia residenziale ma anche dalla realizzazione di nuove infrastrutture, in particolari quelle autostradali. Per affrontare questi problemi, suggerisce Pileri, è necessario ridurre la frammentazione amministrativa e ridisegnare le competenza sull’uso del suolo. Ma -soprattutto- fissare un limite agli abusi di suolo, secondo gli esempi strategici raccolti in tutta Europa. L’autore si spende infine per una vera e propria “pedagogia dei suoli”: un’educazione che investa tutti, dalla scuola, alla politica, dai singoli cittadini agli amministratori. Il nostro Paese – primo al mondo – ha inserito nella Costituzione, all’articolo 9, la tutela del paesaggio. “I padri Costituenti – scrive Pileri – intuirono infatti che il suolo era la registrazione vivente di una storia fatta di mille incroci, ibridazioni e stratificazioni. Dobbiamo nostra questa intuizione. Il suolo non si salva da solo: siamo noi che dobbiamo salvarlo: una delle battaglie civili e culturali più importanti per il nostro Paese”.
“Se oggi non vediamo il legame tra asparagi nel nostro piatto e suolo agricolo là fuori – né lo vedono i nostri giovani – significa che dobbiamo prima ricomporre questa disgiunzione così profonda e strutturale. Negli ultimi 30-40 anni la relazione cruciale tra noi e l’ambiente è stata letteralmente rimossa dal nostro orizzonte culturale in nome e per conto di altri interessi più ‘seduttivi’ che, a viva forza, sono entrati nel nostro immaginario”.