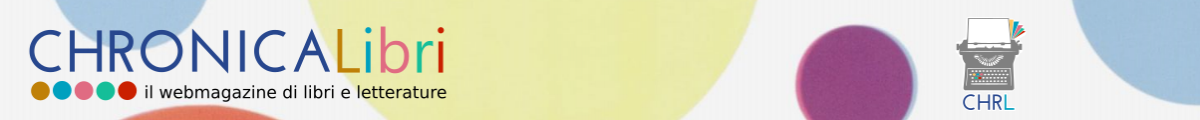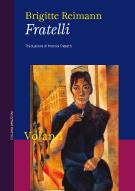ROMA – Elisabeth e Uli sono fratello e sorella. Sono cresciuti insieme in un paesino della Germania Orientale, si sono sostenuti a vicenda, hanno condiviso momenti difficili e creduto negli stessi ideali. La vita li ha messi di fronte alla Guerra, alla divisione del loro Paese in due mondi incompatibili, dove, inevitabilmente, si deve scegliere da che parte stare.
“Fratelli”, il romanzo di Brigitte Reimann (Voland), racconta la loro storia. Una storia appassionata, poetica, a tratti malinconica, che corre sul filo sottile dei sentimenti.
Il rapporto tra i due protagonisti è fatto di complicità, battibecchi, gelosie e tensioni che la Reimann riesce sapientemente a ricostruire. Intensa e incalzante, la narrazione procede sovrapponendo presente e passato.
È Elisabeth, in prima persona, ad abbandonarsi ai ricordi, quando lei e Uli giocavano a Hänsel e Gretel, quando le strade erano attraversate dai carri armati, quando per la prima volta aveva varcato le soglie del kombinat per dedicarsi alla sua vera passione, la pittura.
Il presente, invece, ci porta al 1960, alla Pasqua di quell’anno. Come sempre, fratello e sorella si ritrovano nella loro vecchia casa per trascorrere insieme le feste.
L’atmosfera è allegra, forse troppo. E, infatti, proprio come “un’ombra che il pomeriggio d’estate oscura il sole”, ecco che su Elisabeth piomba un’inaspettata confessione. Uli ha deciso: si trasferirà a Ovest, ad Amburgo. Per lei è un colpo durissimo. Quella che, almeno superficialmente, potrebbe sembrare una reazione prettamente emotiva, in realtà nasconde tanto altro. A poco a poco, tra i due, si apre una voragine. Lo scontro è duro, serrato. Allo sconcerto e alle emozioni dell’una si oppongono le lucide e rassegnate argomentazioni dell’altro.
Elisabeth è un’idealista, una “piccola sognatrice incallita”, ma anche una giovane donna combattiva, pronta a difendere le sue idee e quelle del socialismo. Uli non crede più a niente, è arrabbiato e deluso, nella sua vita vuole costruire navi ma si sente “a pezzi, prigioniero dietro una grata di stupidità e burocrazia”.
Così si va avanti tra accuse, forti e concitate, e momenti di tenerezza che sembrano poter rimettere tutto in discussione. Il contrasto non si esaurisce nel semplice tentativo di Elisabeth di ridestare nel fratello i vecchi ideali condivisi, ma finisce per scavare in profondità, nell’intimo dei due personaggi, riuscendo a portare alla luce dubbi e insicurezze sepolti sotto un apparente equilibrio.
L’interrogativo finale può essere solo uno: meglio andarsene con la dolorosa consapevolezza di avere “la coscienza sporca” o restare sperando di “armare di nuovo la barca e veleggiare in mare aperto”?
Anno: 2013
I “Sogni di sabbia” e il paese dell’uomo bianco.
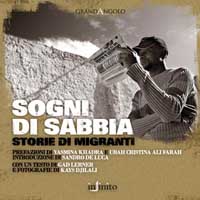 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – A Lampedusa non si è ancora chiusa la contabilità dei morti dell’ultimo incidente. Il naufragio del 3 ottobre scorso ha riacceso i riflettori sulla problematicità delle traversate dall’Africa all’Europa, ridestando le coscienze e sorprendendo ipocrisie e omertà. Ma le morti delle persone che partono dalle coste africane per raggiungere l’Europa, per fuggire guerre e torture, per salvare sé stessi e le proprie famiglie, per poter almeno sperare in un orizzonte migliore, sono silenziose, non fanno né rumore né notizia, non sgomentano coscienze né scuotono dubbi. E dietro ogni rotta, dietro ogni partenza, ci sono volti, ci sono storie, ci sono ragioni e motivazioni diverse. “Sogni di sabbia”, il libro fotografico edito dalla Infinito Edizioni nella collana GrandAngolo, è una sorta di Spoon River migrante (e “clandestina”). Le foto rigorosamente in bianco e nero di Kays Djilali raccontano alcune persone candidate a essere “aspiranti clandestini”, ovvero migranti in partenza che, una volta approdati in terra europea, avranno scarsissime possibilità di mettersi in regola con le severe leggi europee sull’immigrazione. Sono gli harraga, coloro che “bruciano la frontiera”, che partono pur non potendo, sperando di arrivare.
Le fotografie, questi occhi e questi volti, questi sorrisi e questi sguardi, sono stati colti in vari luoghi, nel 2006: da Algeri a Madrid. Ovvero, tra coloro che ancora attendono (e sperano) una partenza a chi invece è riuscito ad attraversare il “mare di mezzo” e a stabilirsi, in qualche maniera. Ad accompagnare le immagini, ci sono le testimonianze. C’è la storia del calzolaio Youssouf, ivoriano, che lavora in Algeria per mantenere la famiglia, ma che ha chiaro come il concetto di “frontiera” sia solo un palliativo: “Laddove il destino ti porta, è lì che rimani”. C’è la storia di Mehdi, un marocchino arrestato in Libia mentre tentava di raggiungere l’Italia: “Conosco dei marocchini che sono morti. È l’angoscia che li ha uccisi. E la tortura”. C’è la storia di A., un camerunense che vive in un ghetto al Algeri: “Ho visto gente diventare pazza. Non hanno più niente per andare avanti né per tornare indietro”, imprigionati in un deserto che non conosce resurrezioni. E c’è la storia di Chaibi Mohamed che cerca suo figlio, Benchaa, scomparso il 13 febbraio 2006: “Vorrei sistemare una stanza speciale per mio figlio e metterci tutte le sue foto e le sue cose e chiuderla”. E c’è la storia di C., un altro camerunense che racconta l’attraversamento verso le coste mediterranee: “Seppelliamo i nostri fratelli nel deserto”. E la traversata del Sahara la ricorda anche Haddane Koné, ivoriano: “Mi ricordo, durante il cammino, di aver portato i miei amici sul dorso, gli ho dato da bere, ho dato loro il mio respiro”. Tutti coloro che partono sono uomini, sono donne, spesso sono bambini. Non sono clandestini; sono solo persone in movimento che cercano la libertà, il benessere, la rivincita. Spesso, pensando esclusivamente alle proprie famiglie. Ma, per tutti, “il paese dell’uomo bianco è lontano, / non ci si può andare in treno. // Il paese dell’uomo bianco è difficile”.
I 10 Libri per combattere la noia
 ROMA – La tanto chiacchierata e temuta crisi economica ci ha logorato: più tasse, meno distrazioni, più preoccupazioni. Il pessimismo dilagante spesso ci contamina e l’arrivo dell’inverno non può far altro che aumentare la nostra insofferenza verso tutto e tutti. E’ a questo punto che la noia fa capolino nelle serate piovose, nei pomeriggi cupi e nei week end uggiosi. Allora bisogna trovare un modo per combattere, bisogna cercare uno spiraglio di sole da fare entrare nelle nostre giornate: questo può essere un libro. Un buon libro, ovvero 10 Libri per combattere la noia.
ROMA – La tanto chiacchierata e temuta crisi economica ci ha logorato: più tasse, meno distrazioni, più preoccupazioni. Il pessimismo dilagante spesso ci contamina e l’arrivo dell’inverno non può far altro che aumentare la nostra insofferenza verso tutto e tutti. E’ a questo punto che la noia fa capolino nelle serate piovose, nei pomeriggi cupi e nei week end uggiosi. Allora bisogna trovare un modo per combattere, bisogna cercare uno spiraglio di sole da fare entrare nelle nostre giornate: questo può essere un libro. Un buon libro, ovvero 10 Libri per combattere la noia.
1. “Le piccole virtù” di Natalia Ginzburg, Einaudi
2. “I sette pazzi” di Roberto Arlt, Sur
3. “Retablo” di Vincenzo Consolo, Sellerio
4. “Amori ridicoli” di Milan Kundera, Adelphi
5. “L’inizio e la fine” di Irène Némirovsky, Via del Vento
6. “A cuore aperto” di Elie Wiesel, Bompiani
7. “La donna di scorta” di Diego De Silva, Einaudi
8. “Finché c’è prosecco c’è speranza” di Fulvio Ervas, Marcos Y Marcos
9. “Middlesex” di Jeffrey Eugenides, Feltrinelli
10. “Con gli occhi chiusi” di Federigo Tozzi, Bur
Cavallo di ferro: “Effatà”, quando è la storia a parlare
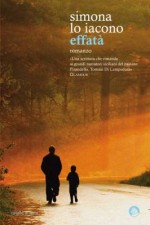 Giulia Siena
Giulia Siena
ROMA – “Anche se non può sentire, ci sono mille modi per far capire al mondo che lui è Nino e che per i nomi c’è sempre un motivo”. Nino non sente e non parla: le sue orecchie sono scatole vuote e la sua bocca non articola i suoni che donano la libertà e il dignità anche ai bambini della sua età. Infatti Nino è un bambino e “non è facile alla sua età, quattro palmi d’altezza, capelli biondi e orecchie sorde, farsi rispettare dal nugolo di ragazzini che girellano per i vicoli sotto zazzere nere infestate da pidocchi carnagioni olivastre e udito buono. Non è facile”. Non è facile nella Sicilia del primo dopoguerra: qui arrivano Nino e sua madre. Lui è un bambino diverso e la madre non è come tutte le altre donne dell’isola; lei è un’attrice tornata dall’Inghilterra alla sua terra natia. Lei, la mamma, recita al Teatro Luna e Nino si lascia incuriosire da una buca che si trova nascosta sotto le assi del palcoscenico. Scopre, così, che da quella postazione privilegiata, osservando il via vai degli attori, si può immaginare un mondo che non conosce e sentire la propria voce che sente graffiargli la gola. Nino viaggia con la fantasia, aiutato dalle movenze e dall’affetto del maestro di buca, un misterioso omaccione cieco. Tra loro nasce una profonda amicizia: insieme si compensano e insieme possono “dettare” i tempi e le scene dello spettacolo che ogni giorno prende vita al Teatro Luna. Da questo scenario parte “Effatà”, il romanzo di Simona Lo Iacono pubblicato da Cavallo di Ferro. La scrittrice-giudice torna in libreria con una storia che si muove su due piani narrativi differenti e paralleli: Siracusa e Norimberga, la città tedesca che ospitò i processi dei principali criminali di guerra davanti al Tribunale Militare Internazionale. Infatti, alla storia di Nino si alterna a quella del dottor Karl Krauser, uno dei medici che aderì al programma di eugenetica del regime nazista. I protagonisti sono, quindi, due bambini che in due differenti periodi e luoghi vissero la loro diversità: entrambi sordomuti ed entrambi curiosi ed intelligenti da capire il mondo circostante e apprendere anche quello che per la scienza non potevano.
“Effatà” è una parola aramaica, una parola dal fascino arcaico e profetico: “apertura al suono”, apertura naturale verso qualcosa che può essere udito anche non avendo la capacità dell’ascolto. “Effatà” è un libro intenso, una storia che è un magistrale intreccio tra fatti realmente accaduti, fantasia narrativa e fattore emotivo.
“La piccola bibbia del matrimonio perfetto”, la guida la sposa wedding planner
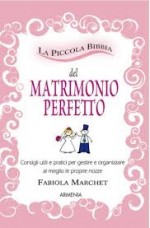 ROMA – “Avete deciso di convolare a giuste nozze. Che lo vogliate o no, a meno che non cerchiate di demandare il più possibile la gestione dei vari passaggi, i mesi che precedono il fatidico giorno saranno tanto emozionati quanto impegnativi e stressanti”. Se avete in mente tutto questo, “La piccola bibbia del matrimonio perfetto” fa al caso vostro. Scritto da Fabiola Marchet e pubblicato dal Gruppo Editoriale Armenia, questo libro è un supporto efficace e indispensabile per organizzare un matrimonio e calendarizzare al meglio tutti i piccoli grandi impegni per arrivare al fatidico sì, evitando – non cosa da poco – di cadere nel tanto temuto kitsch!
ROMA – “Avete deciso di convolare a giuste nozze. Che lo vogliate o no, a meno che non cerchiate di demandare il più possibile la gestione dei vari passaggi, i mesi che precedono il fatidico giorno saranno tanto emozionati quanto impegnativi e stressanti”. Se avete in mente tutto questo, “La piccola bibbia del matrimonio perfetto” fa al caso vostro. Scritto da Fabiola Marchet e pubblicato dal Gruppo Editoriale Armenia, questo libro è un supporto efficace e indispensabile per organizzare un matrimonio e calendarizzare al meglio tutti i piccoli grandi impegni per arrivare al fatidico sì, evitando – non cosa da poco – di cadere nel tanto temuto kitsch!
Decidere il periodo, la location, il tema, gli addobbi, i vestiti, le bomboniere; non dimenticare nessuno dei particolari che renderanno unico quel giorno e, allo stesso tempo, non farsi prendere dal nervosismo, dall’ansia e dalla stanchezza, sono i piccoli grandi ostacoli da affrontare e superare prima del gran giorno. Ma di tutto questo non dovete preoccuparvi: al vostro fianco, ora, c’è “La piccola bibbia” e tutta la lungimiranza e l’attenzione di Fabiola Marchet che vi accompagna passo dopo passo e senza intoppi verso un grande successo.
Si parte subito con individuare il periodo del matrimonio: primavera, estate, autunno o inverno. Tutte le stagioni, infatti, donano agli sposi e al ricevimento un grande fascino: il sole, il calore e la luce dei giorni di primavera ed estate, la freschezza e i colori dell’autunno e il fascino e le grandi atmosfere dell’inverno. Dopo aver scelto il fatidico giorno, tutto il resto è una naturale conseguenza: location, tema, vestiario, addobbi floreali, cibo e torta. Allora si entra nel vivo del libro, si passa alle fasi concrete dove alla teoria si passa alla pratica con esempi, curiosità e piccole accortezze.
Auguri!
Intervista ad Angela Nanetti: la tutela dell’infanzia passa anche dai libri
 ROMA – Angela Nanetti vive per scrivere, ma la sua vita è fatta anche di altro. Osserva, ascolta e trascrive le esigenze dell’infanzia. Negli anni ha dedicato la sua scrittura ai bambini e ai ragazzi, perché la scrittura è una forma per tutelare e stimolare il bambino in una delle tappe fondamentali della vita dell’uomo, l’infanzia. Abbiamo incontrato Angela Nanetti e con lei abbiamo parlato di scrittura, premi e progetti.
ROMA – Angela Nanetti vive per scrivere, ma la sua vita è fatta anche di altro. Osserva, ascolta e trascrive le esigenze dell’infanzia. Negli anni ha dedicato la sua scrittura ai bambini e ai ragazzi, perché la scrittura è una forma per tutelare e stimolare il bambino in una delle tappe fondamentali della vita dell’uomo, l’infanzia. Abbiamo incontrato Angela Nanetti e con lei abbiamo parlato di scrittura, premi e progetti.
Cos’è la scrittura per Angela Nanetti?
La scrittura è una passione, un bisogno fondamentale, un lavoro che richiede grande disciplina e dona un senso profondo.
Angela Nanetti ha una lunga esperienza nel campo della letteratura per ragazzi; come è cambiato negli anni il modo di scrivere per i più piccoli?
Il mio scrivere è sempre rivolto ai ragazzi, naturalmente dando vita e voce a personaggi reali, tengo conto dei mutamenti sociali e di costume che avvengono con il tempo. La mia convinzione è che mentre muta il mondo esterno, però, i processi interiori e psicologici cambiano con grande lentezza. I bisogni fondamentali rimangono immutati, come tappe cruciali della crescita.
Si può coltivare, tutelare l’infanzia attraverso la letteratura?
Io penso che l’infanzia, come prima tappa della storia dell’uomo, vada rispettata nelle sue caratteristiche (psicologiche e pedagogiche) che la rendono unica e la separano dalle altre età. La ricchezza dell’infanzia non sta solamente nelle capacità che vanno potenziate e coltivate, ma nella stessa naturalità di questa età, nello sguardo che l’infanzia ha del mondo, gli occhi pieni di curiosità e di sorpresa con i quali guarda al mondo. Questo va tutelato e mantenuto come risorsa fondamentale per il genere umano, la base da cui partire per andare avanti, le fondamenta su cui costruire la persona che sarà in futuro il bambino di oggi. Nei miei libri ho voluto raccontare questa modalità di essere bambino. I libri – e molte altre cose del quotidiano – sono degli strumenti per crescere bene e con rispetto.
Tutelare l’infanzia ma, allo stesso tempo, anche spronare la naturale curiosità del bambino anche attraverso le parole dei libri.
Come si sceglie il linguaggio adeguato a questa età?
Scrivere per l’infanzia non è semplice e non deve esserlo poiché è in questa fase che il bambino apprende e diventa il lettore di domani. Esiste, infatti, anche una letteratura per ragazzi caratterizzata da un linguaggio piccolo e ripetitivo; mentre penso che all’infanzia si dovrebbe riservare la qualità più alta: una letteratura fatta di parole giuste che spronino la naturale curiosità del bambino.
Abbiamo letto qualche mese fa “Piccole donne oggi” delle Nuove Edizioni Romane. Come è nato questo libro?
Ho appoggiato l’idea di Claudio Saba, l’editore, non pensando assolutamente di trascrivere il romanzo della Alcott. Ho voluto, invece, affrontare questo nuovo progetto come una sfida personale con me stessa: ho voluto ricreare una famiglia ma ho cercato di mettere nelle pagine di questo romanzo tutta la modernità del nostro tempo e ho tracciato dei personaggi caratterizzati da psicologie e modalità differenti tra loro in cui si ritrovano sia ragazze che ragazzi. Infatti, andando nelle scuole, ascoltando il feedback del pubblico, mi sono sorpresa a scoprire che “Piccole donne oggi” è stato un libro molto apprezzato anche dai ragazzi.
Qualche mese fa è uscito per Giunti “La città del circo Pop Corn”, un libro in cui inadeguatezza ed emarginazione spiccano come risorsa, mentre, la sua prima esperienza nella scrittura per “adulti” con “Il bambino di Budrio” è tra i cinque finalisti del Premio Neri Pozza.
Sì, devo ammettere di essere molto soddisfatta per questi risultati. “La città del circo Pop Corn”è un libro che affronta tematiche fondamentali: Giacomo ha una fragilità emotiva che lo spinge a infilare le dita nel naso, un gesto demonizzato dagli adulti ma, che per questo bambino, rappresenta un rifugio dalle paure. Invece, ritrovarmi tra i cinque finalisti (tra le 1781 proposte) del Premio Neri Pozza con “Il bambino di Budrio” è stata davvero una grande sorpresa. Questo libro, la prima esperienza per me con un romanzo per il vasto pubblico, è la storia di un fallimento umano e di un’infanzia tradita. Per me è stato un grande lavoro, perché siamo nel Seicento e il contesto è quello ecclesiastico: bisognava, quindi, ricostruire un mondo lontano ed entrare nella psicologia maschile.
“Senza paura verso il divenire meticcio!”. ChronicaLibri intervista Andrea Staid.
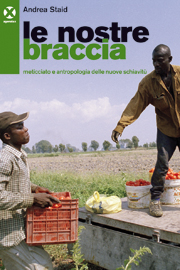 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – La globalizzazione l’abbiamo voluta. Il libero scambio, l’euforia di internet, la sensazione desiderata di sentirsi parte di un immenso “villaggio globale” dove le distanze si annullassero e le particolarità di annichilissero. La globalizzazione, però, porta con sé anche alcuni obblighi, che per tanti, adesso, sono diventati indesiderati. La libera circolazione umana, inarrestabile, improcrastinabile, rimette in gioco l’identità, attiva dei meccanismi di ri-definizione, di ri-valutazione. Non possiamo ancora farci resistenti all’idea, all’inevitabile futuro di incontri e tangenze. Di tutto questo, e anche di molto altro, ne abbiamo parlato con Andrea Staid, giovane storico e antropologo, che ha pubblicato per AgenziaX il saggio “Le nostre braccia”, dove si analizza il processo del meticciato e dove si teorizzano le nuove schiavitù, quelle che alimentano e sostengono le leggi sull’immigrazione, soprattutto extra-comunitaria.
Per questa nostra chiacchierata partirei dal concetto di “meticciato” perché la parola stessa (affascinante di per sé) ha subito, negli ultimi tempi, una sorta di riabilitazione semantica. Se fino a qualche tempo fa il lemma “meticcio” veniva utilizzato con un’ombra denigratoria e infamante, anche grazie al tuo saggio è evidente come le prospettive si siano ampliate e aggiornate. Persino sul piano della narrativa ha trovato spazio il grande esperimento di Wu Ming 2, con il ridefinito “romanzo meticcio”, ovvero un romanzo costruito tramite testimonianze, materiali d’archivio, memorie, interviste, fotografie, e anche creazione narrativa. Cosa si intende, oggi, per “meticciato” e come lo si può vivere e sperimentare concretamente?
Il meticcio è l’incontro, l’ibridazione tra culture diverse, ma non dobbiamo malintendere questo concetto, perché come ci ricorda Laplantine, non esistono individui originariamente puri, il meticciato si oppone alla polarità omogeneo/eterogeneo. Si presenta come una terza via tra la fusione totalizzante dell’omogeneo e la frammentazione differenzialista dell’eterogeneo. Il meticciato è una composizione le cui componenti mantengono la propria integrità. Non è una fusione, coesione o una specie di osmosi è un confronto tra le tante alterità culturali è quello che manca nelle nostre politiche sociali cioè il DIALOGO. In più non dobbiamo dimenticarci che la storia del Mediterraneo, dell’Europa è fatta da un vero e proprio crogiuolo culturale, di migrazioni continue, avvolte sotto forme di invasioni, conquiste, scontri, saccheggi e deportazioni, ma anche di scambi, confronti, trasformazioni reciproche dei popoli. Il meticcio è al di fuori di tutte le argomentazioni politicaly correct, è un mosaico polimorfo, decostruisce i muri identitari nazionali e sovranazionali. Cosa dobbiamo fare per viverlo e sperimentarlo? Smettere di avere paura, scavalcare i falsi confini del “noi” “loro” in modo da rielaborare i nostri modelli dei rapporti sociali e risistemare le coordinate del mondo vissuto perché le forme della società sono la sostanza della cultura.
E pare proprio la paura il sentimento costante dei nostri Anni Zero e Dieci. Talmente tanta la paura da aver elaborato delle leggi a regolare l’immigrazione che sono dei veri e propri bunker, anche se pieni di falle e di maglie deboli. C’è chi ha parlato di “Fortress Europe”, una vera e propria fortezza, fatta di frontiere rinforzate e di assurde leggi migratorie. Tu definisci il migrante una “non persona estremamente ricattabile”: perché i migranti fanno paura? Quali sono i nostri timori? Cosa immaginiamo a rischio ipotizzando l’arrivo di altre persone?
L’Europa infatti è una vera fortezza, fatta di confini sorvegliati da eserciti e polizie internazionali, fatta di persone con diritti e di persone uguali a queste ma di serie b, quelle che nel mio libro e prima di me Alessandro Dal Lago ha chiamato “non persone”. “Non persone” perché anche se camminano, mangiano e dormono come noi il fatto che non hanno il permesso di soggiorno che è solamente un pezzo di carta con un timbro sopra, li fa diventare immediatamente delle persone senza nessun diritto, ovvero non persone estremamente utili per il nostro sistema capitalista che necessita di lavoratori altamente ricattabili senza nessuna possibilità di rivendicare i propri diritti. I “nostri” timori sono dettati dalla paura del diverso, dal confronto con l’alterità perché troppo spesso tendiamo a rinchiuderci in una falsa e monolitica identità culturale. Come scrive Marco Aime nel suo “Macchia della razza, storie di ordinaria discriminazione” ormai siamo come quei tifosi che non inneggiano più alla loro squadra, ma passano novanta minuti a insultare gli avversari, tifosi che hanno fatto dei colori di una maglia una terra di appartenenza per cui vale la pena combattere, fare male, persino uccidere. Una terra non da amare, ma utile a odiare gli altri.
E per dominare le nostre paure, per illuderci di essere più sicuri nelle nostre vite, ci siamo inventati una legge sull’immigrazione che, come tu sostieni nel tuo saggio, incentiva la clandestinità e favorisce lo sfruttamento. Tu scrivi una cosa significativa nel tuo testo: “l’irregolarità non è un tratto ontologico del migrante, ma è determinata da un dato sistema giuridico”. Sicché è lo stato, paradossalmente (ma non troppo), che crea e favorisce la clandestinità, definita però al tempo stesso come reato. Quali sono i meccanismi per cui lo stato esercita questa sua ambivalente funzione? In nome di cosa si dispone di altre vite con una pratica burocratica alienante?
La legge italiana è particolarmente ridicola per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori. Praticamente è una legge che produce clandestinità. Un migrante una volta arrivato in Italia se non ha già un datore di lavoro non ha nessuna possibilità di essere regolarizzato. L’unica possibilità che trova davanti a sé è quella di lavorare in nero super sfruttato, senza nessun tipo di diritto. Il problema non riguarda poi solo il mondo del lavoro ma anche quello della casa: senza documenti trovare una casa è un odissea, e molti italiani se ne approfittano chiedendo affitti allucinanti per piccoli appartamenti o singole stanze da condividere. Ma non è finita qua senza documenti i migranti si vedono negare anche uno dei diritti più fondamentali cioè quello della libertà di movimento, si muovono il meno possibile e sempre con la paura di essere fermati e rinchiusi in un CIE o in un carcere senza aver commesso nessun reato. La seconda domanda invece contiene anche la risposta, la burocrazia è alienante e crea per dirla come David Graeber spazi morti nell’immaginazione degli esseri umani. Più semplicemente tramite cavilli burocratici, leggi sempre più restrittive si crea disuguaglianza, sofferenza e si condannano migliaia di esseri umani alla nuova schiavitù.
Ed è forse ancora più agghiacciante pensare che al giorno d’oggi si siano ripristinate, con la complicità e l’omertà dello stato, nuove forme di schiavitù. Una schiavitù che non soltanto condanna all’estrema precarietà i migranti ma che condiziona spesso i rapporti anche tra di loro, come tu scrivi in un paragrafo del tuo libro. In particolar modo tu analizzi un caso specifico, quello delle badanti. Noi siamo oramai abituati a queste figure che son diventate essenziali per la nostra esistenza, ma difficilmente immaginiamo – o abbiamo la pazienza di immaginarci – le dure condizioni nelle quali vivono e lavorano. Perché questo fenomeno è interessante all’interno della tua lettura etnografica? Quali considerazioni permette di elaborare?
Il capitolo sulle badanti analizza proprio un caso specifico, perché oltre allo sfruttamento la maggior parte di queste donne vivono una situazione di segregazione, di vero dominio e controllo da parte del datore di lavoro. In più analizzando bene le conversazioni che ho avuto con le badanti esce fuori un altro aspetto centrale che è quello di sentirsi trattate come delle macchine tappa buchi. Da non sottovalutare poi che sono le precarie per eccellenza nel mondo del lavoro nero perché la durata del loro impiego è strettamente legata alla vita del loro assistito. Per le considerazioni che permette di elaborare invece lascio la parola a una donna che lavora in Italia come badante che molto meglio di me sa esprimere ed elaborare quello che è la condizione di queste giovani donne: “Mio amato marito, emigrate diveniamo immortali. Mai nate, non siamo state cresciute, non invecchiamo, non ci stanchiamo, non moriamo. Un’unica funzione: lavorare. Immortali poiché continuamente interscambiabili. Esisterà la fine del lavoro, ma non c’è limite alle forme del servire”.
Sicché quali sono le possibili prospettive? Quali le avverabili soluzioni? Quali possono essere le decisioni coraggiose da prendere per trasformare la migrazione da ancestrale (e irrazionale) paura a effettivo momento di scambio e crescita, di compiuto meticciato?
Per smettere di avere paura bisogna accettare una interazione egualitaria con gli altri, dobbiamo saper costruire identità dai confini aperti e pronti al cambiamento. L’identità può avere una valenza positiva e riconoscersi negli altri e una negativa nella quale scoprirsi e definirsi in base a ciò che ci differenzia dagli altri. La valenza positiva porta verso il pensiero meticcio che contrasta il falso universalismo e il mito della purezza, questo avviene tramite un processo dinamico di scambi reciproci, di accettazioni e di rifiuti, di rinunce e di appropriazioni. Dobbiamo essere consapevoli dei tanti possibili errori, delle difficoltà, degli incontri e degli scontri, ma anche essere forti della necessità di accettare la complessità del reale, perché la complessità deve diventare il fondamento della nostra identità. Quindi senza paura verso il divenire meticcio!
“Guerra alla Cina”, l’inaudita invasione secondo Jack London.
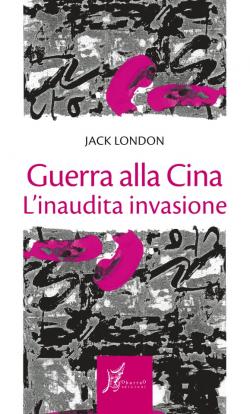 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Nel 1904 Jack London seguirà la guerra russo-giapponese: sarà uno dei primi corrispondenti a sporcarsi di guerra, a pedinarla, a seguirla direttamente sui campi dove la guerra si svolgeva, dove lasciava morti e cadaveri. La Cina era balzata agli onori delle cronache e all’interesse del mondo in particolar modo con la Rivolta dei Boxer, la ribellione anticolonialista e xenofoba esplosa gli ultimi giorni del XIX secolo e i primi del XX e repressa nel sangue. Ma Jack London fu tra i primi a conoscerla empiricamente, a traghettare in occidente un’immagine particolare del grande “impero celeste”. “The Unparalleled Invasion” (edito in Italia dalla ObarraO Edizioni con il titolo di “Guerra alla Cina”) uscì nel 1910 e suscitò grande interesse nell’opinione pubblica. Alla fine dell’800 i tanti cinesi degli States erano stati assunti a capri espiatori della disoccupazione galoppante e della crisi che imperversava furiosa: si parlava niente meno che di Yellow Peril, di pericolo giallo.
Lo spettro della Cina, di questo immenso capitale umano, veniva agitato in molte sedi e in altrettante occasioni. “Il risveglio del dragone” preoccupava, angosciava principalmente perché nessuno conosceva i veri numeri, le potenzialità, la reale potenza di quello che era un immenso continente ignoto. Poco avevano a che fare col razzismo, tutte queste ansie. Il problema fondamentale non era tanto la provenienza etnica (né l’appartenenza religiosa) quanto lo spettro di un rivale che fosse ancora più potente, di uno scontro che avesse come destino finale quello della sopraffazione e della sconfitta del ricco Occidente. Angosce che comparvero anche nella letteratura, attraverso la quale si cercava finanche una qualche forma di sublimazione, di catarsi mentale, di antidoto.
London partorì questo breve scritto di difficile definizione: da pamphlet a brevissimo racconto fantapolitico, tutte le nomenclature stanno strette perché mettono in luce alcuni aspetti ma ne trascurano altri. La scrittura di London è giornalistica, coincisa e accattivante. Illude che si tratti di un reportage, di un’attenta e profonda analisi della situazioni, mentre invece è una sorta di accelerata spirale che approda, poi, a un inedito e inatteso epilogo. London analizza i processi che hanno portato l’avvicinamento del Giappone alla Cina e il risveglio delle coscienze cinesi, il suo orgoglio e la sua straordinaria volontà di riscatto. London immagina e ipotizza un universale conflitto, tra Cina e resto del mondo, il cui culmine coincide con il Bicentenario della Rivoluzione Americana. Immagina e ipotizza un conflitto, principalmente economico, che viene in breve tempo vinto dalla Cina e ipotizza un finale apocalittico, in cui con uno stratagemma da guerra omerica il resto del mondo pianifica una sorta di “soluzione finale”. Rimane da capire quanto sia finzione e quanto sia profezia.
“Tre amiche sul ghiaccio”: fermata Parigi
 Marianna Abbate
Marianna Abbate
ROMA – Quando non frequenti per tanto tempo un posto, tornandoci scopri in ogni crepa del muro il tempo che è passato. È stato così anche per me quando ho di nuovo preso in mano un libro della collana “Il battello a vapore” di Piemme. I libri per ragazzi hanno cambiato stile, genere e soprattutto forma e aspetto.
A partire dalla copertina, che ricorda moltissimo i disegni dei comics per ragazze. La disegnatrice è Caterina Giorgetti, quella di “Witch” per intenderci, sono stata una grande fan di quel fumetto eme ne sono accorta subito.
I tempi sono cambiati e si sente ad ogni pagina di questo libro. Scritte un po’ grandi, le parole si intrecciano ai disegni, aiutando l’immaginazione di chi non è abituato a leggere.
Per fortuna i valori sono ancora gli stessi: l’amicizia prima di tutto, la lealtà, lo spirito sportivo del fair play, l’impegno e… l’amore. L’autrice della saga “Tre amiche sul ghiaccio” è Mathilde Bonetti, un’appassionata pattinatrice eterna ragazzina, che in questa puntata ci racconta il viaggio delle ragazze del Palastella a Parigi. Parigi on ice è il titolo del volumetto appena stampato, che racconta le avventure di Angelica Cleo e Sadia, promettenti campionesse del pattinaggio artistico. Insieme realizzano il sogno di pattinare nella Ville Lumiere, e affrontano coraggiosamente le scelte che cambieranno totalmente la loro vita.
Il libro ha il pregio di appassionare allo sport, di stimolare nelle bambine il desiderio di lavorare in gruppo per realizzare il successo.
L’editore consiglia questa lettura per bimbe tra i 9 e gli 11 anni, l’età più sognante.
Domani in libreria: “Venga pure la fine”, il nuovo romanzo di Roberto Riccardi
 Giulia Siena
Giulia Siena
ROMA – “E adesso venga pure la fine, venga pure la notte. Sono pronto ad accoglierle. Venga pure un nuovo inizio, perché è solo quando tutto finisce che incomincia davvero qualcosa“.
Arriva in libreria domani, mercoledì 25 settembre 2013, “Venga pure la fine”, il nuovo romanzo di Roberto Riccardi pubblicato dalle Edizioni e/o nella collana Sabot/age, diretta da Colomba Rossi e curata da Massimo Carlotto. “Venga pure la fine” è un’invocazione, una presa di coscienza, un arrendersi, un donarsi, un abbandonarsi al dovere e a quello che sarà. “Venga pure la fine” è la nuova e inattesa indagine di Rocco Liguori, il tenente dei Carabinieri già protagonista di “Undercover. Niente è come sembra”.
Questa volta dovrà recarsi all’Aia a disposizione del Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia. In quella terra ad Est lui c’è già stato, sette anni prima, nel bel mezzo di un conflitto fraticida che ha segnato la storia della Bosnia. Allora, anche se doveva rimanerne fuori per questioni politiche, Rocco Liguori aveva arrestato il macellaio di Gračanica, quel Milan Dragojevic colpevole della strage di Srebrenica e di altri eccidi in una terra costantemente lacerata dalle lotte. Dopo l’arresto tra loro cominciò un rapporto epistolare intenso, fatto di riflessioni e consapevolezza. Liguori ora deve tornare su quei passi, deve tornare in ex-Jugoslavia per indagare sul tentato suicidio di Dragojevic. Il colonnello, infatti, è in coma; probabilmente ha ingerito una massiccia dose di quei farmaci con i quali doveva combattere un nuovo nemico, la depressione. Ma la storia del tentato suicidio, per un uomo che ha procurato tanto male al suo stesso popolo, non regge. Il procuratore vuole che Liguori scopra di più. E Rocco lo fa, vorrebbe esimersi ma non può; vorrebbe anche evitare di tornare con la memoria e con gli occhi a quelle terre che sono state lo scenario della sua folgorazione per Jacqueline. Anni prima, infatti, proprio in Bosnia aveva incontrato questa “miscela di armonie silenziose che culminavano in un sorriso radioso e una voce cristallina”, una donna che gli aveva scombussolato i sensi e gli aveva dato buone idee per la cattura del colonnello. Ora lo scenario è cambiato, gli anni Novanta sono lontani, rimangono, però, gli antichi rancori nello sguardo risoluto di kosovari e bosniaci e l’indagine di Liguori prende, improvvisamente, rotte internazionali. La storia tiene dentro altre storie (magistrale il riferimento al libro di Elsa Morante) e viaggia velocemente su piani temporali diversi; il palcoscenico su cui si muovono i personaggi è un susseguirsi a velocità impressionate di città Europee: L’Aia, Sarajevo, Cracovia, Londra, Roma, come a ricordarci che la criminalità non risparmia niente, nessuno e in alcun luogo.
Roberto Riccardi – vincitore con “Undercover” della seconda edizione del Premio Letterario Mariano Romiti – firma un nuovo e avvincente romanzo, un libro in cui alla padronanza della materia si aggiungono sfumature e dettagli che solo un ottimo narratore può carpire.
“La vita non torna indietro a offrirti di correggere uno sbaglio. Lei è già altrove, a decidere per qualcun altro che, come te, si crede eterno ed è solo l’ennesimo granello nella polvere del tempo. La vita non torna indietro, non lo fece neppure quel giorno”.
Guarda QUI la video intervista a Roberto Riccardi realizzata con ItvRome.