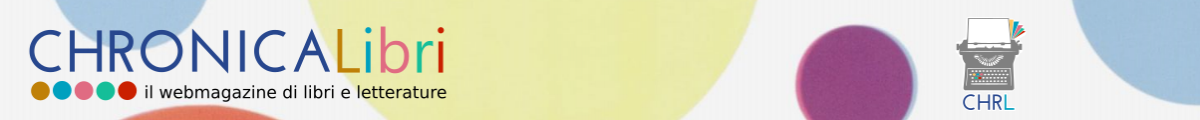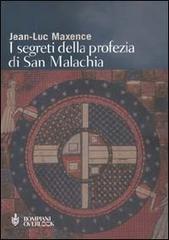 Michael Dialley
Michael Dialley
AOSTA – “Durante l’ultima persecuzione che subirà la Santa Chiesa Romana, regnerà Pietro il Romano. Egli pascerà le pecore fra molte tribolazioni. Passate queste, la città dei sette colli sarà distrutta, e il Giudice tremendo giudicherà il popolo”: questo dovrebbe essere ciò che spetterà all’uomo e, in particolare, alla Chiesa cattolica a breve, dopo l’elezione del successore di Benedetto XVI. Nello specifico è il 112° motto in latino che chiude la profezia di Malachia, così come racconta il saggio “I segreti della profezia di San Malachia” di Jean-Luc Maxence, edito da Bompiani nel 2000: il lettore viene accompagnato nella comprensione di questa profezia, a lungo studiata e che, così come ogni questione legata in qualche modo al soprannaturale, crea ipotesi e congetture.
Sono motti che identificano ciascun papato, partendo dal 1143 fino all’ultimo, collocato genericamente tra il 2000 e il 2031/2032; tale profezia in realtà è stata resa pubblica solo nel 1595 e non si conosce la vera natura di questi oracoli, tant’è che nel saggio non si analizzano quelli che sono precedenti al 1595, proprio perché potrebbero essere stati scritti postumi ai pontificati.
È straordinario pensare a come qualcuno abbia potuto scrivere questi incisi, spesso di poche parole, che raccontano un intero papato, ma è ancora più stupefacente quanto, anche dopo 400 anni dalla pubblicazione della profezia, questi motti possano coincidere effettivamente con il pontefice al quale si riferiscono: ovviamente si tende a pensare al pontefice in quanto singolo, ma Maxence ci aiuta a comprendere quanto in realtà ci si riferisca al papato e, talvolta, al periodo che coincide con un determinato governo pontificio. È un viaggio attraverso i secoli, attraverso tutti i successori di Pietro che rende il lettore partecipe della vita del Vaticano, affascinante e misteriosa: l’autore cerca di contestualizzare i motti analizzando il papato e la personalità del pontefice in questione e ne emerge per ciascuno un ottimo ritratto, nonché un’analisi sintetica ma efficace delle varie fasi della storia della Chiesa cattolica nei secoli. Durante ogni conclave ecco rievocata la profezia; addirittura nei secoli precedenti (e sicuramente per l’elezione di Clemente VIII, negli anni di pubblicazione della profezia) si utilizzavano questi motti per condizionare il risultato dell’elezione, mentre poi dal Settecento si è guardato a questi come una linea guida da mantenere durante il pontificio regno.
Oggi, nel 2013, ecco che viene ancora tirata in ballo la profezia di questa figura misteriosa, vaga, di San Malachia (importante personalità del XII irlandese), proprio in occasione dell’imminente conclave che ha due aspetti piuttosto inconsueti e nuovi: il primo l’elezione di un nuovo pontefice in seguito alle dimissioni, e non alla morte, del precedente; il secondo legato alla profezia stessa, in quanto questo sarà l’ultimo papa della storia della Chiesa cattolica.
Può affascinare, o far sorridere: l’autore ne dà un’interpretazione il più possibile legata a fatti storici concreti; nulla è dato all’immaginazione e alla pura congettura; ognuno ne tragga ciò che crede, riconoscendo, però, l’aspetto suggestivo che questa profezia porta con sé da 418 anni.
Anno: 2013
Se, dovendo parlare di letteratura, lo scrittore non parla che del sé…
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Ogni anno, qualcheduno lo deve pur vincere. E poco importa se i papabili e i meritevoli son più dell’unico posto in palio; e ancor meno importa se i pronostici non ci indovinano mai e se anche il Nobel per la letteratura è diventato oramai più un premio politico che di merito letterario. Hemingway non sbagliò quando mandò a dire all’Accademia di Svezia: “Lo scrittore che sappia quali altri grandi scrittori non abbiano ricevuto il Premio più solo apprestarsi a riceverlo con umiltà. Non serve elencarli”. Ma elencarli potrebbe anche servire, per capire come la miglior scrittura non si possa individuare soltanto in un personaggio scelto per ogni anno, tra la massa di scrittori e poeti che popolano il mondo. Pochi son stati coloro che l’han rifiutato, molti son stati coloro che l’hanno vinto a sorpresa, neppure con disinvolti meriti.
Ciascun premio Nobel è anche ‘obbligato’, nel ricevere il premio, a tenere un discorso “a commento dell’essenza della letteratura e della direzione che essa sta prendendo” (cito John Steinbeck nel 1962). Sorprende – ma non troppo – l’appassionata disinvoltura di alcuni premi Nobel nell’, invece, autoincensarsi, nel parlare referenzialmente di sé stessi e delle proprie opere, trascurando il generale e dedicandosi all’odioso (e castrante) particolare. TerrediMezzo editore ha raccolto in un bel volume, “I Nobel per la letteratura si raccontano”, i discorsi tenuti da alcuni dei premiati, da Pablo Neruda a Herta Muller, da J.M. Coetzee a Doris Lessing. Ed è divertente addentrarsi nei loro commenti a un premio che, inutile negarlo, dà prestigio letterario ma soprattutto dà tanto prestigio economico. Pamuk costruisce una storia di tradizione familiare, offrendo come correlativo oggettivo la valigia del suo babbo, carica e colma di fogli scritti e vicende abbozzate; Saramago si offre al lettore nelle vesti di un volenteroso apprendista, che scrive per dar sfogo agli impulsi nati in lui da una realtà feroce e carnivora; Faulkner si autoproclama attuatore di alti impegni morali: “Sento che questo premio non è stato conferito a me come persona, ma alla mia opera, il lavoro di una vita nel tormento e nella fatica dello spirito umano, non per la gloria e men che meno per il profitto, bensì per creare dal materiale dell’animo umano qualcosa che non esisteva prima. Pertanto, di questo premio sono solo l’amministratore fiduciario”. E via, ancora avanti con lo sproloquio. Le parole sane e utili di altri scrittori, come l’eccezionale apologia del “non-lo-so” della Szymborska o la profezia della Lessing sull’Africa, affamata di cultura, impallidiscono, ahimè, di fronte alla sicurezza erculea di altri scrittori nel conferirsi meriti e importanza, nel concedersi la prerogativa di aver inventato la scrittura; nel tributarsi l’assurda profezia di essere gli ultimi scrittori a poter calpestare la terra (e sfiorare il cielo) del nostro pallido pianeta.
Il Vaticano, protagonista indiscusso tra fantasia e realtà.
 Marianna Abbate
Marianna Abbate
ROMA – Di libri sui segreti complotti del Vaticano ne sono stati scritti molti. Alcuni sono esageratamente fantasiosi, altri inquietanti. E poi c’è “Il curatore segreto del Vaticano” di Umberto Vitiello, pubblicato da qualche settimana da Lupo Editore.
Il romanzo immagina un futuro vicino, dove la Chiesa sta cercando di riorganizzarsi, lottando contro le impurità interne nell’intento di ritornare alle origini del cristianesimo. Trama abbastanza ingenua e irreale, se non fosse che l’attualità sembrerebbe quasi dare ragione all’immaginazione dell’autore. Per Vitiello la trasformazione dovrà avvenire durante un segretissimo concilio, da svolgersi in un luogo misterioso e isolato come una tranquilla abbazia montana. Ovviamente la pacifica location è tutt’altro che sicura, a tratti ricorda moltissimo l’impervio monastero del “Nome della rosa”, e diventa subito dalle prime pagine teatro di un terribile omicidio su un aspirante monaco dalla storia complicata e dal passato sospetto.
Grazie all’aiuto di uno dei monaci che abitano l’abbazia, che per caso era dottore in economia, si risolvono e vengono svelati i terrificanti segreti della banca vaticana.
Il libro è interessante dal punto di vista della costruzione, tuttavia devo ammettere che a volte l’innegabile erudizione dell’autore rallenta un poco la trama: forse è questo il punto debole del romanzo. Tuttavia tutte le fila sembrano ricongiungersi in maniera abbastanza nitida, e questo è sicuramente un punto a favore dell’esperienza di Vitiello.
Più che un vero e proprio thriller, nonostante gli ingredienti fondamentali siano mistero, omicidio e deduzioni, si tratta di un romanzo suspense con una strizzata d’occhio alla storia e, inaspettatamente, all’attualità.
Il pericoloso “circo” della Truffa
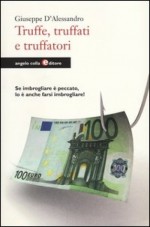 Luigi Scarcelli
Luigi Scarcelli
Parma – Alzi la mano chi, alla parola truffa, non pensa alla scena del film TOTO’TRUFFA ’62 in cui il celebre attore napoletano tenta di vendere ad uno sprovveduto turista italoamericano la Fontana di Trevi. Un modo comico di rappresentare un reato molto presente nella nostra società, forse perché è una distorsione dell’arte di arrangiarsi di cui noi italiani siamo maestri.
Lo scrittore Giuseppe D’Alessandro, avvocato esperto prevalentemente di materia penale e responsabilità professionale, ha voluto riprendere lo stesso tono ironico di quel film per raccontare il mondo della truffa nostrana nel libro “Truffe, truffati e truffatori”, pubblicato da Angelo Colla Editore.
Il libro è diviso in capitoli a seconda del tipo di truffa trattato (immobiliare, di gioco, a sfondo sessule…) permettendo al lettore di iniziare la letture in maniera “arbitraria” dal capitolo contente l’argomento più di suo interesse.
Ogni truffa viene descritta tramite una lunga serie di casi reali presi da sentenze o dalle cronache giornalistiche. La scrittura è volutamente ironica e affronta in tono leggero, ma comunque informativo, un problema molto presente nella società moderna. Gli esempi descritti, come detto, sono molti e forse in qualche punto l’autore avrebbe potuto soffermarsi in maniera più dettagliata su un numero minore di casi in modo da dare più “respiro” alla lettura. Il risultato comunque è molto buono dato che la scelta stilistica si sposa bene al tema della truffa che di per se è tragicomico.
Quello che scaturisce dal libro è un mondo fatto di astuzie, ingenuità, malizia e soprattutto furbizia, anzi mi si passi il termine “furbettizia” riferendomi a quel tipo di furbetti tanto di moda nel nostro Paese che cercano in maniera scorretta o sleale di aggirare ostacoli di qualsiasi tipo allo scopo di trarne un vantaggio personale. Il bello è che i furbetti non sono solo i truffatori, ma anche i truffati stessi, che abboccano a promesse di facili “guadagni” di qualsiasi tipo rimanendo vittime della loro stessa ingordigia da finti “dritti”.
L’autore descrive prevalentemente casi dell’epoca recente, soffermandosi anche in paragoni con sentenze per truffa dell’inizio del secolo scorso. Il lettore potrà notare la palese differenza di gravità tra quelle che erano considerate (e punite come tali) le truffe negli anni ’30 (ad esempio il caso di una persona condannata nel 1933 per il “riutilizzo” di una busta per lettere affrancata) e quelle di oggi. Se ciò sia dovuto ad un profondo cambiamento della nostra mentalità e del nostro stile di vita (magari più egoistico e smaliziato) o solo al diverso sistema giuridico dell’Italia di allora (ricordiamo che si parla dell’Italia Fascista) può essere un ulteriore spunto di riflessione per il lettore di questo libro, che non mancherà di far riflettere sorridendo.
Mucchi Editore: sognare altri mondi e storie possibili
Silvia Notarangelo
ROMA – “Il prodotto di ciò che facciamo è il libro, un elemento prezioso che da secoli accompagna l’uomo nella sua crescita culturale e personale e che alimenta la voglia e la capacità di sognare altri mondi e storie possibili”. È questa la filosofia che ha guidato al successo Mucchi Editore, casa editrice di respiro internazionale, attenta a cogliere i mutamenti della realtà contemporanea senza dimenticare il valore di una tradizione più squisitamente letteraria.
La storia di Mucchi Editore affonda le radici nella lontana corte estense e, da allora, con determinazione, ha saputo affermarsi nel panorama editoriale. Quale il segreto di questo successo?
La nostra storia è fatta di circa 360 anni di esperienza in cui l’attività editoriale si è intrecciata con quella tipografica, attraverso la fede nella parola scritta di diverse generazioni. Oggi il cuore del nostro lavoro si fonda solo sull’editoria, e nonostante le numerose difficoltà del settore, conserviamo ancora quell’ingenuo ottimismo secondo cui la letteratura e l’uso che il soggetto ne fa possa rendere migliori, intessendo dei legami virtuali con il “diverso”. La lettura in questo senso ci fa muovere verso l’altro e riesce a restituire il senso più alto del concetto di dialogo.
La vostra proposta editoriale è ricchissima e, nel tempo, ha saputo rinnovarsi, dando spazio anche ad approfondimenti di carattere politico, sociologico, antropologico ed economico. Quali ambiti del sapere dovrebbero, attualmente, essere al centro di maggiore attenzione?
Il nostro catalogo deve la sua varietà al rapporto costruito e consolidato negli anni con vari dipartimenti universitari, dall’ambito giuridico, a quello filosofico, letterario e filologico.
Tuttavia oggi gli ambiti su cui vogliamo investire maggiormente sono la saggistica letteraria, la filosofia, e gli approfondimenti legati al contemporaneo, senza tralasciare importanti contributi per le scienze giuridiche. In particolare, di recente abbiamo battezzato tre nuove collane: LetterePersiane, collana curata da Luigi Weber, in cui scommettiamo ancora sull’utilità della critica, arte tutt’altro che inutile in un tempo complesso come questo, il cui compito non è quello di aggiungere complessità a complessità, bensì di spezzare, come voleva Kafka, la crosta del mare ghiacciato dentro di noi: renderlo nuovamente liquido, mobile, vitale. Cerchiamo quindi di lavorare su una forma meno paludata e accademica, più in sintonia con il presente e aperta a nuove contaminazioni e tangenze con la sociologia, l’arte, la filosofia, la storia. Abbiamo inaugurato la serie con la ristampa aggiornata del famoso libro di Massimo Fusillo L’altro e lo stesso. Teoria e storia del doppio, un libro diventato un classico del genere, ma ormai fuori catalogo da diverso tempo. Si prosegue con il testo di Massimiliano Borelli Prose dal dissesto . Antiromanzo e avanguardia negli anni sessanta, nell’anno che celebra il cinquantenario del Gruppo 63, e altri lavori di giovani studiosi sono già in programma.
L’altra collana a cui teniamo molto è Prismi, quella appunto legata agli approfondimenti di carattere politico, sociologico e tutto quello che ruota intorno al mondo contemporaneo, con una lettura trasversale delle problematiche e delle idee che lo agitano. Dopo il testo di Pierfranco Pellizzetti, Libertà come critica e conflitto. Un’altra idea di liberalismo, pubblicheremo a breve un lavoro sugli ecosistemi narrativi nell’attuale panorama contemporaneo, e dopo sarà la volta di riportare a galla l’attualità delle parole di Antonio Gramsci con gli studi di Angelo D’Orsi. L’ultimo tassello è rappresentato dalla filosofia, e in particolare dal nuovo lavoro collettivo Officine Filosofiche, guidato dal prof. Manlio Iofrida, anche qui allarghiamo un po’ il discorso alla situazione storico-politica, dato che il tipo di filosofia che esso cercherà di rilanciare non si colloca in una dimensione teoretica e astorica,ma, al contrario, intende rivendicare la sua appartenenza alla storia…
Chi sono i destinatari privilegiati delle vostre proposte?
Data la natura della nostra produzione storica il nostro lettore tipo è certamente lo studioso interessato ad approfondire determinati temi, ma tra gli intenti dei nuovi progetti c’è appunto quello di allargare la nostra base dei lettori e raggiungere un pubblico più ampio. In tal senso cerchiamo di comunicare i nostri libri in maniera trasversale e tangibile tramite l’interazione con tutti i nostri canali social, siamo infatti presenti su Facebook, twitter, pinterest, anobii e youtube, lavorandoci quotidianamente. Crediamo che questi strumenti permettano un contatto costante con lettori, blogger, giornalisti e autori, amplificando quello che vogliamo trasmettere.
Quali sono, se ci sono, le difficoltà che deve affrontare, oggi, una casa editrice?
Le difficoltà più grandi per una piccola realtà come la nostra sono di certo lo scoglio della distribuzione e un mercato editoriale asfissiato sempre di più da concentrazioni delle varie filiere, oltre all’appiattimento verso il basso della qualità, per cercare di star dietro a mode commerciali. Dal canto nostro proviamo a rimanere a galla nel modo più onesto possibile, perseguendo sempre la selezione critica e sperando naturalmente che le risorse investite possano dare anche qualche frutto concreto.
Operare a Modena, in una realtà locale più piccola ma culturalmente vivace, è un valore aggiunto?
Modena ha un’antica tradizione editoriale e conta un certo numero di case editrici. La nostra stessa storia è strettamente connessa con le vicende della città, anche se sin dagli inizi la nostra produzione, oltre alla storia locale ha avuto un respiro nazionale. Inoltre, negli anni si è affermato e consolidato in città un festival dedicato alla piccola e media editoria (BUK), che ogni anno cresce sempre di più in termini di presenze. Questo di certo ha favorito la conoscenza della nostra produzione in città e il confronto. Inoltre, cerchiamo sempre di costruire relazioni sul territorio, rendendoci promotori di incontri ed iniziative culturali.
Progetti o iniziative particolari per il 2013?
Per il 2013 ci concentreremo in particolare sulle nuove collane attivate, con una massima cura del testo e attenzione ad ogni dettaglio, dalla grafica delle copertine, che non consideriamo un aspetto meramente funzionale, all’editing vero e proprio, avvalendoci, ove possibile anche di collaboratori esterni. Altra sfida da cui non possiamo più prescindere è il digitale. Dopo un timido inizio riservato ai periodici e a qualche pubblicazione, stiamo cercando di riorganizzare un po’ la nostra filiera interna per convertire una selezione del nostro catalogo, oltre ad alcuni progetti in cantiere pensati esclusivamente per il digitale.
Libri Come, IV edizione per la Festa del Libro e della Lettura a Roma dal 14 al 17 marzo
 ROMA – E’ in programma dal 14 al 17 marzo 2013 presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma la IV edizione di Libri come, Festa del Libro e della Lettura. “Come l’Europa” sarà il tema di quest’anno della manifestazione promossa e organizzata dalla Fondazione Musica per Roma; un viaggio alla scoperta del nostro continente, attraverso il filtro delle parole, delle analisi e delle riflessioni degli scrittori: tra politica ed economia, cultura e società, crisi e futuro.
ROMA – E’ in programma dal 14 al 17 marzo 2013 presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma la IV edizione di Libri come, Festa del Libro e della Lettura. “Come l’Europa” sarà il tema di quest’anno della manifestazione promossa e organizzata dalla Fondazione Musica per Roma; un viaggio alla scoperta del nostro continente, attraverso il filtro delle parole, delle analisi e delle riflessioni degli scrittori: tra politica ed economia, cultura e società, crisi e futuro.
Appuntamento ormai abituale del panorama letterario nazionale, quest’anno Libri come ha idealmente abbracciato l’intera stagione invernale, grazie a una intensa serie di anteprime che ha visto come protagonisti Serge Latouche, Javier Marías, Sylvie Goulard, Mario Monti e Wilbur Smith e che si concluderà – sempre all’Auditorium – giovedì 6 marzo alle 10.30 con Giuliano Amato (Lezioni dalla crisi) e domenica 10 marzo alle 19 con David Grossman (Come un romanzo racconta il dolore).
Dal 14 marzo, si svolgerà la Festa vera e propria, che quest’anno si focalizzerà fin dal titolo sull’Europa, sui suoi malumori, sulle sue prospettive. A una folta pattuglia di autori internazionali (Javier Cercas, Petros Markaris, Fernando Savater, Catherine Dunne, Angelica Klüssendorf, Uwe Timm, Frank Westerman, Miljenko Jergović, Dragan Velikić, Matti Rönkä) sarà chiesto di ragionare su sfide e problematiche che avvolgono il presente e il futuro del continente, in un ciclo di incontri che comprenderanno anche due maratone collettive (la prima affidata agli scrittori, la seconda a un gruppo di sociologi, economisti e accademici).
Nell’ambito di Libri come si ragionerà anche sull’Italia, in alcuni appuntamenti caratterizzati dalla presenza di giornalisti (Pierluigi Battista, Filippo Ceccarelli) ed esponenti della società civile (Susanna Camusso, Stefano Rodotà). Inoltre, uno spazio molto ampio sarà concesso ai protagonisti della narrativa e della saggistica, spesso coinvolti attraverso lo stimolante percorso del dialogo. L’elenco degli ospiti è molto lungo: comprende scrittori (Simonetta Agnello Hornby, Niccolò Ammaniti, Andrea Bajani, Aldo Busi, Andrea Camilleri, Massimo Carlotto, Gianrico Carofiglio, Giancarlo De Cataldo, Maurizio De Giovanni, Paolo Di Paolo, Richard Ford, Marco Malvaldi, Antonio Manzini, Romana Petri, Alessandro Piperno, Zeruya Shalev, Walter Siti), giornalisti (Concita De Gregorio, Paolo Mauri, Andrea Vianello), filosofi (Giorgio Agamben, Massimo Cacciari, Umberto Galimberti), economisti (Tito Boeri, Guy Standing), psicanalisti (Massimo Recalcati), registi (Ermanno Olmi), docenti universitari (Giovanna Cosenza). Nel programma non mancheranno appuntamenti di natura “spettacolare” (dal concerto di Laurie Anderson, alla lezione d’arte del regista Peter Greenaway, fino ai reading di Nanni Moretti e Fabrizio Gifuni) oltre ad approfondimenti sul mondo dell’editoria (dalle tavole rotonde Come il libro. Sfide e proposte e Come ho scritto il mio primo libro all’incontro con Roberto Calasso sulla storia di Adelphi), naturali per una manifestazione che storicamente nasce con l’obiettivo di non fermarsi al cosa (i libri), ma di esplorare anche il come (come vengono scritti, stampati, distribuiti). La Festa si chiuderà, la sera di domenica 17, con un evento speciale: una conversazione con lo scrittore anglo-indiano Salman Rushdie, che dialogherà con un ospite a sorpresa.
Particolarmente ricco nell’edizione 2013 è anche il programma del Garage di Libri come, l’officina che come da tradizione ospita laboratori interattivi, reading, tavole rotonde (sull’Europa e sulla violenza sulle donne), presentazioni di libri. Tra le decine di ospiti che transiteranno dalle tre sale del Garage, spesso impegnati in diversi eventi, ci saranno scrittori (Ritanna Armeni, Mauro Covacich, Diego De Silva, Marco Lodoli, Dacia Maraini, Melania Mazzucco, oltre ad Anna Premoli, protagonista di una delle prime storie di successo del self publishing in Italia), poeti (Valerio Magrelli), giornalisti (Armando Massarenti, Antonio Monda, Gianni Mura, Stefania Ulivi), politici (Giuliano Amato, Stefano Fassina, Antonio Tajani), magistrati (Ferdinando Imposimato, presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione), personalità del mondo della musica (Ennio Morricone, Fiorella Mannoia) e del cinema (Margherita Buy).
Ulteriore conferma dell’edizione 2013 della Festa è il programma rivolto agli studenti. Quest’anno, un doppio progetto coinvolgerà i ragazzi delle scuole medie e delle superiori, con lezioni sull’evoluzione del linguaggio e sul giornalismo (tra gli insegnanti, protagonisti dell’informazione in Italia come Enrico Mentana, Fiorenza Sarzanini e Riccardo Staglianò).
“Delitto a Villa Ada”, il movente poetico di un omicidio
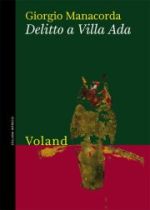 ROMA – “E più sono intelligenti più sono pericolosi, creda a me che li conosco. Quello che è successo a Villa Ada si spiega solo così”.
ROMA – “E più sono intelligenti più sono pericolosi, creda a me che li conosco. Quello che è successo a Villa Ada si spiega solo così”.
A differenza di tutti quelli che a Villa Ada ci vanno solamente per la corsa mattutina, Vasco Sprache nella villa ci vive e lo fa come un barbone. Nonostante sia un poeta conosciuto e un uomo di bell’aspetto, Sprache ha fatto del parco la sua casa e personalizza i viali appendendo agli alberi le sue poesie. Un giorno, però, viene ritrovato morto. Da questo delitto partono le indagini del commissario Sperandio, figlio di professori universitari e ultra quarantenne con il pallino per la poesia. Sperandio, infatti, è tra coloro che tutte le sere, dopo lavoro, si dedicano a comporre versi e la mattina, prima di recarsi a lavoro, con qualsiasi clima, si reca a Villa Ada per correre. E Sperandio conosce bene il parco e i suoi anfratti e, attraverso gli interrogatori per scoprire il colpevole del delitto, conosce anche tutti coloro che corrono e hanno un qualche rapporto con la poesia. Tra questi c’è Giorgio Manacorda, il professore universitario in “odore di nobel” che ha ritrovato il cadavere di Vasco Sprache.
Giorgio Manacorda in “Delitto a Villa Ada” – pubblicato da Voland – diventa personaggio, maggior indiziato per l’omicidio e forse vittima anche lui di un mistero che si gioca sul filo del verso poetico.
La trama del racconto è avvincente e il libro si dipana fino all’ultima pagina arricchendosi di colpi di scena e rimandi letterari (i nomi degli indiziati sono i cognomi di poeti italiani celebri, l’amicizia dell’autore con Pasolini, il ruolo “banalizzato” della poesia e lo scontro perenne tra ispirazione poetica e qualità letteraria). Autoironico e irriverente è Manacorda che scrive una favola noir dalle sfumature linguistiche e stilistiche degne del suo nome e del suo personaggio anche fuori dal romanzo.
Da Ponte e Vienna: quando la cultura era più che politica.
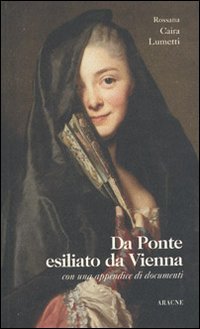 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Il 1790 fu anno cruciale, per l’Austria e il suo impero. Morì Giuseppe II, sovrano “illuminato” e attento alla cultura come manifestazione di prestigio e di potere. Leopoldo II ne prese il posto, deludendo le attese: al potere imperiale non riuscì a esser così liberale come durante il suo granducato in Toscana (per primo nel mondo, abolì la pena di morte nel 1786). Il sospetto, l’ansia, la fobia delle rivolte corrompono non soltanto il sistema politico, ma investono anche la cultura e i suoi rappresentanti; in particolare, coloro che della libertà di espressione e di seduzione han fatto le loro bandiere. Lorenzo Da Ponte è l’emblema di come la cultura, in ogni luogo e in ogni tempo, sia sempre stata vista con diffidenza da chi detiene il potere e sa (generalmente) che è pericolosa, perché fa sapere troppo. Ma veramente soltanto questi sono i motivi della caduta in disgrazia di Da Ponte, scelto da Giuseppe II come poeta di corte? Può esser stata fatale a Da Ponte solamente la scelta di libretti arditi e di tematiche scottanti? Può essergli costata la tranquilla e rispettata vita viennese solamente la sua liberalità, la lungimiranza e il suo spirito libertino? Rossana Caira Lumetti, nel suo testo “Da Ponte esiliato da Vienna” (Aracne editrice, 1996), getta una luce importante nella vicenda, presentando anche dei documenti inediti in italiano, tra cui un pamphlet, “Anti – Da Ponte”, nel quale si descrive un immaginario processo contro il canonico trevigiano, reo, tra le altre accuse, di aver copiato numerose opere di suoi colleghi.
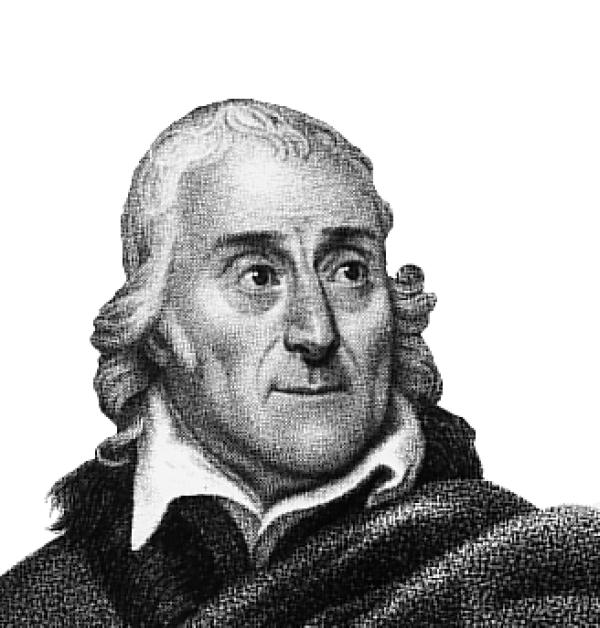 La studiosa sottolinea come le motivazioni dell’allontanamento di Da Ponte da Vienna, che fecero cominciare i suoi peregrinaggi in tutta Europa per poi concludersi nei neonati Stati Uniti (dove fondò la cattedra di letteratura italiana alla Columbia University), furono ben più numerose e varie. Alla base, persino un odio personale: Da Ponte dimostrò subito le sue spiccate capacità imprenditoriali, entrando in contrasto con personalità di spicco della cultura viennese, tra i quali il Rosenberg e l’Orsini; ma anche con i grandi poeti della corte, in particolare con Casti. Da Ponte fuggì le unità aristoteliche, rinnegandole come materia gretta e inutile; mise in scena personaggi libertini e spregiudicati, quasi prendendo a modello i grandi personaggi del ‘700 europeo, che per l’ultima volta furono italiani (sé stesso, Casanova, Cagliostro); cercò un coinvolgimento del pubblico anche a livello metanarrativo e musicale, attraverso continue allocuzioni e apostrofi al pubblico in sala. Fatale fu per Da Ponte il nuovo senso di maggior disinvoltura e spregiudicatezza nell’arte e nei suoi allestimenti che stava cominciando ad affermarsi negli intellettuali di fine ‘700, in un’epoca che traghettò alla fine del mecenatismo e della commissione, e attestò la nascita della cultura come mestiere autonomo e indipendente.
La studiosa sottolinea come le motivazioni dell’allontanamento di Da Ponte da Vienna, che fecero cominciare i suoi peregrinaggi in tutta Europa per poi concludersi nei neonati Stati Uniti (dove fondò la cattedra di letteratura italiana alla Columbia University), furono ben più numerose e varie. Alla base, persino un odio personale: Da Ponte dimostrò subito le sue spiccate capacità imprenditoriali, entrando in contrasto con personalità di spicco della cultura viennese, tra i quali il Rosenberg e l’Orsini; ma anche con i grandi poeti della corte, in particolare con Casti. Da Ponte fuggì le unità aristoteliche, rinnegandole come materia gretta e inutile; mise in scena personaggi libertini e spregiudicati, quasi prendendo a modello i grandi personaggi del ‘700 europeo, che per l’ultima volta furono italiani (sé stesso, Casanova, Cagliostro); cercò un coinvolgimento del pubblico anche a livello metanarrativo e musicale, attraverso continue allocuzioni e apostrofi al pubblico in sala. Fatale fu per Da Ponte il nuovo senso di maggior disinvoltura e spregiudicatezza nell’arte e nei suoi allestimenti che stava cominciando ad affermarsi negli intellettuali di fine ‘700, in un’epoca che traghettò alla fine del mecenatismo e della commissione, e attestò la nascita della cultura come mestiere autonomo e indipendente.
Uri Orlev, avere 13 anni nel campo di concentramento
 Marianna Abbate
Marianna Abbate
ROMA – Avere tredici anni è di per sé abbastanza complicato. Viviamo le nostre tragedie personali: ai maschi cambia la voce e le femmine cambiano significato. Avere tredici anni è un po’ una maledizione: pensiamo di sapere già tutto, ma nessuno ci crede.
Avere tredici anni ed essere un poeta è terribile. Gli amici ci prendono in giro, i grandi ci guardano con quell’indulgenza che odiamo.
Trovarsi in un campo di concentramento è inspiegabile al profano. Il campo è un posto fuori dal tempo, fuori dallo spazio. Non è solo una prigione per il corpo: il campo è un ladro di anime. Il campo ci trasforma, ci rende mostri ai nostri stessi occhi.
Tredici anni e il campo di concentramento non sono due cose che vanno d’accordo. A tredici anni siamo troppo assorbiti dalla nostra tragedia interiore per comprendere appieno quello che accade intorno a noi, soprattutto se siamo dei poeti.
E se l’uomo adulto non riesce a cantare col piede straniero sopra il cuore, tra i morti abbandonati nelle piazze, nel poeta bambino vince la creatività. Non solo: si tratta di una creatività vivace.
 I versi del tredicenne Uri Orlev non sono disperatamente tristi. Lo spirito fanciullo desidera sfogare la propria creatività, nonostante tutto. Uri riempie il suo preziosissimo taccuino di versi, ricopiati con attenzione dall’asse di legno usata per la brutta copia. Oggi queste poesie sono pubblicate in italiano ed ebraico da Giuntina, nel piccolo tomo “Poesie scritte a tredici anni a Bergen- Belsen (1944)”.
I versi del tredicenne Uri Orlev non sono disperatamente tristi. Lo spirito fanciullo desidera sfogare la propria creatività, nonostante tutto. Uri riempie il suo preziosissimo taccuino di versi, ricopiati con attenzione dall’asse di legno usata per la brutta copia. Oggi queste poesie sono pubblicate in italiano ed ebraico da Giuntina, nel piccolo tomo “Poesie scritte a tredici anni a Bergen- Belsen (1944)”.
E’ evidente il contrasto tra le rime semplici e la scrittura infantile, in contrapposizione alle tematiche gravissime e ad una innaturale autocoscienza. Il bambino cresciuto troppo presto, non riesce a vedere con nitidezza tutti i significati della realtà che lo circonda, tuttavia ha sviluppato un ottimo senso dell’osservazione. La trasposizione poetica della realtà vista con gli occhi curiosi di Uri, assume un’ironia involontaria quasi grottesca. Lo sguardo invidioso del ragazzo che vede gli altri detenuti grattare il fondo della pentola, mentre lui stesso cerca di frenare i morsi della fame con le rimanenze di quell’educazione, che una volta aveva un significato totalmente diverso, ci colpisce al cuore. Perché quei volti scarni, quelle teste rapate, quei numeri sul braccio tornano ad avere un nome, una storia.
Queste poche poesie non hanno un gran valore letterario. Come vi ho accennato le rime sono semplici e la struttura basilare. Le metafore, poi, non sono proprio azzeccatissime.
Quello che è interessante è il significato socio-antropologico di questi testi. Se a scrivere una poesia sul lager fosse stato un adulto, la parola tragicommedia nel titolo della poesia ci avrebbe indignati. L’invidia stessa ci avrebbe indignati.
Nella poesia “E la vita va avanti” troviamo un punto di vista molto interessante. Il piccolo poeta contrappone la quotidiana banalità delle conversazioni, alternandola anche graficamente verso per verso, agli orrori della guerra. L’intenzione di Orlev era quella di mostrare quanto il desiderio di sopravvivenza, il bisogno di parlare di banalità, permettano all’uomo di estraniarsi dagli avvenimenti che lo circondano. Questa sagace e intelligente osservazione avvicina i suoi versi a quelli della poetessa premio Nobel Wislawa Szymborska. La stessa poesia è stata poi corretta e sistemata da un compagno di prigionia con più esperienza.
Effettivamente l’opera corretta, mostra appieno il potenziale del poeta.
Orlev da grande ha fatto lo scrittore per ragazzi, scrive prevalentemente in ebraico, ma queste prime poesie sono state scritte in polacco. Le sue opere sono state insignite, tra l’altro con il premio Andersen, il riconoscimento più alto per un autore di libri per l’infanzia.
“1001 monasteri e santuari in Italia da visitare almeno una volta nella vita”, viaggio nell’Italia spirituale e non solo
 Giulia Siena
Giulia Siena
ROMA – “Questa guida vuol essere uno strumento per scoprire le bellezze spirituali dell’Italia, e con esse la storia, la cultura, la ricchezza artistica e naturalistica che le circonda”. Sono 1001 i luoghi di culto che Chiara Giacobelli raccoglie nel libro “1001 monasteri e santuari in Italia da visitare almeno una volta nella vita” pubblicato da Newton Compton. Delle tante ricchezze artistiche e spirituali disseminate sul suolo italico, la scrittrice e giornalista marchigiana ne seleziona 1001; 1001 luoghi che hanno fatto la storia. Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, dalla Toscana alla Puglia passando per Umbria e Sardegna, questo libro ci accompagna in un itinerario ricco di sorprese archeologiche, bellezze naturalistiche e aneddoti storici. In Italia, come in nessun’altra nazione al mondo, infatti, si conta un così alto numero di conventi, monasteri, abbazie e cattedrali, luoghi che nei secoli sono stati punti di aggregazione e crocevia di rilievo.
Il viaggio di Chiara Giacobelli – già autrice di “101 cose da fare nelle Marche almeno una volta nella vita” – parte dalla Valle d’Aosta, con il Convento di Santa Caterina, costruito sui resti di un antico anfiteatro romano (probabilmente uno dei più antichi del mondo) che accoglieva fino a 15.000 persone. Oggi, il convento non è solo un luogo di culto, ma anche una importante sede archeologica. La Basilica Papale di San Francesco ad Assisi si trova al numero 576 di questo intenso viaggio per l’Italia. La basilica, che custodisce le spoglie del Santo, è tra le principali destinazioni religiose e dal 2000 è stata proclamata patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Ma il libro raccoglie anche diverse curiosità: sapevate, ad esempio, che la Sacra di San Michele, in Piemonte, si erge al centro di una via di pellegrinaggio lunga più di duemila chilometri, che unisce quasi tutta l’Europa occidentale da Mont Saint-Michel a Monte Sant’Angelo in Puglia?
Allora – nonostante il libro sia abbastanza voluminoso – mettiamolo in valigia e facciamoci accompagnare dall’ottima capacità descrittiva della Giacobelli in un percorso nell’Italia della spiritualità, dell’arte e della storia.